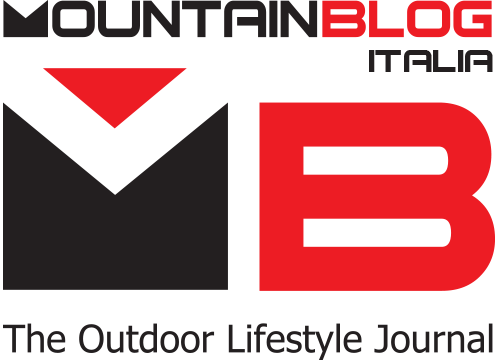Terminato il week end, dopo sopralluoghi e realizzazioni si torna a sognare, progettare e attender poco per le nuove avventure. Il ciclo si ripete costantemente… Vale per gli escursionisti amanti dei sentieri quanto per i più grandi alpinisti, finché il bambino dagli occhi entusiasti che è in noi sopravvive!
Anche questa volta, proprio pensando al fanciullo assetato di avventura, ho deciso di intervistare uno dei protagonisti del panorama alpinistico che fra molti altri si distingue per sete di montagna e mente lucida in grado di portare a termine i propri progetti. Da una scintilla nasce una bella chiacchierata con Marcello Sanguineti…

Da quando vai in montagna e come hai cominciato?
Per me l’alpinismo vero e proprio è incominciato relativamente tardi, intorno ai venticinque anni. Ho iniziato a frequentare le Alpi da adolescente, con mia mamma e mio fratello, nelle valli di Cogne, quando in paese c’era ancora la mitica “Casa Alpina”. Spesso mi sembra che tutto il mio andare in montagna abbia come fine quello di ritrovare le emozioni che provavo durante quelle escursioni nel Gruppo del Gran Paradiso. Un obbiettivo, lo so bene, irraggiungibile. Forse è questa consapevolezza a far sì che, su ogni vetta, alla gioia inquieta si alterni dentro di me un crudele velo di malinconia.

Quale fu la tua prima cima e quale la prima parete?
La mia prima cima fu la Punta Pousset, al termine una gita “EE” (Escursionista Esperto), in Valle di Cogne, insieme a mio fratello e mia mamma. In vetta incontrai “Jean” Crudo, mio mentore: fu con lui che, pochi giorni dopo, calzai per la prima volta i ramponi, per superare un breve tratto di ghiaccio sul pendio terminale della Punta Tersiva (in quegli anni la Tersiva aveva ancora un ghiacciaio degno di questo nome…). Poi fu la volta, insieme a mio fratello, di varie salite classiche in Valle di Cogne, legati a Piero D’Aragona, istruttore del CAI-ULE di Genova. Ricordo con estrema nostalgia quegli anni. La mia prima parete vera e propria, anche se non difficile, fu quella dell’Aiguille Croux, nel massiccio del Monte Bianco.

Hai scalato in gran parte del mondo, quali sono le tre realizzazioni che ami di più?
Sicuramente una è quella che è valsa la nomination al Piolets d’Or: la via “Amman in Kashmir”, che ho aperto nel 2017 nel Karakorum pakistano, insieme a Gian Luca Cavalli e Michele Focchi, sul precedentemente vergine Fiost Brakk (5850m). A parte le difficoltà tecniche (per gli “addetti ai lavori”: sviluppo 1300 m, dislivello 950 m, 6b/AI6X/ED+), si tratta di una scalata portata a termine in totale isolamento e in perfetto stile alpino, con notevoli difficoltà di accesso (il gruppo montuoso si trova in una zona di conflitto fra Pakistan e India), in un massiccio completamente inesplorato. Il Fiost Brakk è immerso in una vera e propria selva di pareti di roccia e ghiaccio, capaci di soddisfare gli appetiti famelici di varie spedizioni… Siamo stati i primi a mettere i piedi in quel circo glaciale: è un esempio di autentico alpinismo esplorativo.
Un’altra realizzazione che fa parte del mio ”magico tris” è “Plein Sud” (900 m, VI, WI4+/5R, M6 +), una via di misto “world class” aperta nel 2010 insieme a Sergio De Leo, Marco Appino e Michelle Coranotte sulla parete S delle Grandes Jorasses. Con i suoi 1400 metri, la S delle Jorasses offre un dislivello circa 200 metri superiore a quello della più famosa N ed è la più alta parete del massiccio del Bianco. Priva di rifugi e bivacchi d’appoggio, difficilmente in condizioni a causa dell’esposizione a sud, è immensa, ma, prima del 2010, contava solo quattro vie, nessuna delle quali ripetuta. Guido Alberto Rivetti ne diede un’eloquente descrizione: una «muraglia infernalmente viva» che «sembra opposta allo sforzo dannato del ghiaccio che vuole entrarle nel cuore». Plein Sud, la quinta via su quella parete, nata a distanza di 25 anni dalla precedente, s’insinua nelle sue pieghe, aprendosi un varco attraverso il gigantesco camino incassato che nel 1985 aveva respinto il tentativo di Gian Carlo Grassi e soci (tentativo conclusosi poi con l’apertura della “Phantom Direct”). Plein Sud ha tuttora una sola ripetizione, ad opera di Matt Helliker e Jon Bracey, nel 2012. Ancora poche settimane, fa un alpinista del calibro di Denis Urubko, che ho incontrato al Congresso Nazionale del Club Alpino Accademico, mi diceva che è sorprendente il fatto di aver scovato, negli anni 2000, una linea del genere ancora vergine nel massiccio del Bianco…
Passando al Sudamerica, mi viene in mente la prima traversata integrale da nord a sud del massiccio dell’Illimani, nel 1998. Ho effettuato scalate ben più impegnative, ma quella salita mi è rimasta nel cuore. È una fantastica cavalcata di circa 16 chilometri di sviluppo, tre dei quali oltre i 6000 metri di quota, effettuata in cinque giorni attraverso zone del massiccio dell’Illimani rarissimamente frequentate dagli alpinisti. Si tratta di una salita che risale a vent’anni fa e, probabilmente, il tempo ha contribuito a renderla, per me, mitica: spesso il pensiero della giovinezza lontana influenza facilmente i ricordi… Fra i compagni di quei giorni non posso fare a meno di menzionare Yossi Brain, persona stupenda e instancabile esploratore e scalatore delle Ande boliviane – purtroppo vittima, nel 1999, di una valanga sul Nevado El Presidente, in Cordigliera Apolobamba.
Infine, devo citare una quarta salita: la Supercanaleta del Fitz Roy. Non si tratta di una “prima”, ma la menziono per una serie di motivi: la Patagonia per me è una terra magica, c’è stata perfetta armonia con i compagni di cordata (Damiano Barabino, che purtroppo non c’è più, e Sergio De Leo) e l’ho portata a termine in un momento particolarmente felice della mia attività alpinistica (ero arrivato due volte in vetta al Fitz Roy a distanza di poco più di una settimana e mi ero portato a casa anche altre due vie, una sull’Aguja Poincenot e una sulla Guillaumet).

Qual’è il tuo più grande exploit?
Rispondo con una battuta, che, però, non è molto distante dalla realtà. Premetto che non vivo fra i monti, ma sulla costa ligure, fra Chiavari e Zoagli. Ritengo una grande fortuna poter combinare le salite in montagna con la vita nel Golfo del Tigullio, a picco sul mare, proprio dove gli ulivi si fondono con la macchia mediterranea e la vegetazione si tuffa tra le scogliere. La “pozione magica” ottenuta da questo connubio, però, ha un prezzo: moltissime salite mi sono costate e mi costano tuttora “diabolici” giochi a incastro con il tempo e gli impegni di lavoro. La maggior parte delle grandi vie che ho salito sulle Alpi sono frutto di partenze poco dopo o poco prima della mezzanotte, lunghi viaggi in auto con il sonno che divora, avvicinamenti iniziati appena sceso dall’auto, ore di scalata dopo aver completamente saltato la notte di sonno, a volte bivacchi in parete, discese con le palpebre rese pesanti dalla stanchezza e, per non farsi mancare nulla, qualche centinaio di chilometri – dovendo rientrare in Università in tempo per una riunione o per far lezione, la mattina. Il mio più grande exploit, forse, è essere sopravvissuto a tutto questo… Battute a parte, le mie realizzazioni più significative sono sicuramente le vie “Amman in Kashmir” in Karakorum e “Plein Sud” sulle Grandes Jorasses, di cui ho parlato sopra.

Quali sono le tre pareti che ami di più?
Difficile rispondere: ho avuto la fortuna di scalare su moltissimi dei “paretoni” dove è stata scritta la storia dell’alpinismo. Limitandomi alle Alpi, a caldo direi: la nord delle Grandes Jorasses, il versante Brenva del Bianco e la nord del Civetta.

Cosa cerchi in montagna?
Non so perché io frequenti così intensamente la montagna. Non lo so e non me lo chiedo: con gli anni ho capito che, se una cosa mi sembra giusta e mi fa sentir bene, va fatta e basta: ricercare l’armonia con me stesso è condizione necessaria per essere in armonia con gli altri.

Quanto e come ti alleni?
Ecco, questo è uno dei miei punti deboli. Non mi alleno con costanza e, detto sinceramente, non so rinunciare a una buona cena – o, ancor più, a un buon aperitivo – per guadagnare un grado. Diciamo che i miei allenamenti sono estemporanei e improvvisati. Finora ce l’ho fatta così, ma temo che, se vorrò mantenere il livello, il passare degli anni mi costringerà a qualche sacrificio in più… che tristezza!

Come si combina la tua vita “extreme” con la famiglia?
Per un verso o per l’altro, la mia vita è tutta un po’ “extreme”, nel senso che è il risultato della sovrapposizione, a volte caotica, di comportamenti e decisioni a volte razionali e a volte irrazionali. Non so quali prevalgano, so solo che il risultato è (per me) un affascinante casino, nel quale mi crogiolo e dal quale, al tempo stesso, vorrei fuggire. Non ho figli – questo, sono sincero, è un grande rammarico. Ho una compagna alla quale sono infinitamente grato per sopportare i miei ritmi e le mie assenze e due nipotini ai quali auguro, a volte, di assomigliare a me e, altre volte, di essere il più possibile diversi dal loro zio. Anche questo fa parte delle contraddizioni di cui è popolata la mia vita.

Qual’è il tuo mestiere e come può combinarsi con la tua attività outdoor?
Nella vita professionale sono professore di Ricerca Operativa all’Università di Genova. Apparentemente, il mio lavoro rappresenta quanto di più diverso dall’alpinismo si possa immaginare; in realtà, è vero il contrario. In sostanza, mi occupo di modellare matematicamente e sviluppare algoritmi risolutivi per complessi problemi di ottimizzazione. Spesso, questo viene fatto scomponendoli in tanti sotto-problemi più semplici: “mettendo insieme” gli algoritmi risolutivi per questi ultimi, si ottengono quelli per i problemi di partenza. Non si tratta forse dello stesso metodo utilizzato dagli alpinisti per concepire e realizzare salite su pareti alte e complesse? I sotto-problemi sono i tiri e ogni lunghezza, a sua volta, è fatta di una successione di altri sotto-problemi, rappresentati da sezioni o singoli passaggi. L’algoritmo complessivo è il modo per realizzare la via che arriva in vetta. La mia professione e il mio alpinismo condividono un elemento per me irrinunciabile: vagabondare in libertà. Libertà degli argomenti e dei metodi di ricerca nel primo caso, libertà di scegliere quale parete scalare, quale itinerario seguire e quale stile utilizzare nel secondo. In sintesi, prima ancora di essere un “malato di montagna”, sono un inguaribile “malato di libertà”.

Quante vie hai aperto? Cosa è importante in esse?
A parte alcune eccezioni, ho iniziato ad aprire vie piuttosto tardi. Per molti anni sono stato soprattutto un insaziabile ed esigente ripetitore: appena leggevo di una grande via da qualche parte nel mondo, non vedevo l’ora di andare a provarla. Partendo dal “mio” mare di Liguria, ho scalato su Alpi, Highlands Scozzesi, Norvegia, Pirenei, Giordania, Oman, Colorado, Wyoming, Utah, Nevada, Montagne Rocciose Canadesi, Québec, Stati Uniti dell’est (Maine, Vermont, New York e New Hampshire), Yosemite, Ande Peruviane e Boliviane, Patagonia, Pamir, Tien Shan, Karakorum, Himalaya dell’India e del Nepal. Sono un “vagabondo della verticale”, come amo definirmi. A causa di questa “smania” di ripetere le grandi salite in mezzo mondo, non ho aperto molte vie: poco meno di una ventina sulle Alpi e poco più di una ventina su montagne extraeuropee. A ogni via nuova che apro chiedo solo una cosa: farmi provare sensazioni nuove da quelle che ho provato aprendo le precedenti.

Qual’è il sogno della tua vita?
Avere tutta la libertà di cui sento il bisogno, senza per questo limitare quella degli altri.

Quali sono state le tue ultime realizzazioni?
Una è sicuramente la salita della nomination ai Piolets d’Or: “Amman in Kashmir”, salita di “misto doc” nel Karakorum. Per quanto riguarda l’attività su ghiaccio, mi piace ricordare una perla del cascatismo mondiale, che ho ripetuto lo scorso inverno: Finnkona, sull’isola di Senja, oltre il Circolo Polare Artico. Più che di una semplice cascata di ghiaccio, si tratta di una salita che, lungo i suoi 400 metri, annovera una prima cascata, un pendio nevoso, una sezione di misto e una goulotte, poste in successione a proteggere il “cuore di Finnkona”: un’impressionante linea di ghiaccio su una parete a precipizio sul fiordo di Bergsfjorden. Infine, su roccia mi viene in mente l’attività alpinistica realizzata la scorsa primavera nell’ambito di una spedizione CAI-JTB (Jordan Tourism Board) in una zona della Giordania che era alpinisticamente ancora inesplorata, dove abbiamo aperto numerose vie trad (integrate a spit nei tratti altrimenti improteggibili) su arenaria. È stata la scoperta di una “piccola Wadi Rum”…

Quale o quali sono i tuoi prossimi progetti?
Unire esplorazione alpinistica e ricerca scientifica. Sto lavorando ad un progetto che prevede obiettivi alpinistici esplorativi combinati ad una attività scientifica declinata in vari modi. In generale, si tratta di acquisire in condizioni estreme una gran quantità di dati (relativi, ad esempio, a prestazioni di tessuti innovativi, monitoraggio di parametri fisiologici, comportamenti psicofisici in condizioni di stress, ecc.), con l’obbiettivo di elaborarli a posteriori mediante tecniche di apprendimento automatico (ad esempio, le reti neurali), che fanno parte della mia attività professionale di ricerca.

Cosa pensi del permesso di salita del Bianco?
Per me l’accostamento dei termini “permesso” e “alpinismo” è un ossimoro. Penso non ci sia bisogno di aggiungere altro.

Cosa diresti a un ragazzo che vuole approcciarsi alla montagna?
Una cosa forse scontata, ma, per me, fondamentale: tener presente che ogni vetta, per quanto alta, è solo un’anticima. Gli direi anche che, dopo essere arrivato in vetta, non resta che scendere, per ricominciare a salire: dovrebbe tenerlo ben presente, se davvero volesse entrare nel “gioco perverso dell’alpinismo”. Ancora una cosa: se abitasse in Riviera, come me, gli direi che alternare in breve tempo l’odore delle conifere a quello del mare eccita incredibilmente, ma gli consiglierei anche di metter da parte un bel po’ di soldi per pagare benzina e pedaggi autostradali…
Christian Roccati
SITO – Follow me on FACEBOOK