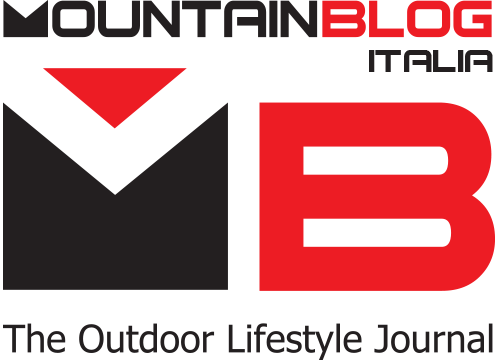Ocean film festival 2019, terza edizione…
Un anno ancora e ancora un volta in sala, pensando alla meraviglia del mare e alle prossime avventure; le luci si abbassano e io sprofondo nel blu dei filmati, nella voglia di bolle e di frangenti. Da tanto tempo, almeno due stagioni, aspettavo il momento in cui godermi questo magnifico spettacolo, il meglio del meglio da tutto il mondo.
Giro per le lande oltre l’ultima frontiera scalando montagne e attraversando terre selvagge, e il richiamo delle acque è chiaro e distinto: il lupo di mare e il vecchio saggio di montagna, sono la stessa persona. A febbraio mi immergevo in solitaria sotto il ghiaccio a Chamois con il monobombola, a marzo surfavo a Nazaré, ad agosto nuotavo nel Mediterraneo ed eccoci all’autunno …è il momento del Festival!

Amico mio, che tu ci creda o meno, non c’è stato momento in quest’anno che non abbia pensato al cantico dell’Oceano. Le voci di Calipso e Poseidone si mischiano e danzano, scivolano all’interno dell’anima e ti prendono il cuore.
Mentre i pensieri viaggiano i filmati incominciano con I’m fragile, un corto della durata di 3 minuti, non un teaser ma un vero e proprio film, che condensa meraviglia e sostenibilità toccandoti l’anima. Il 14 agosto del 2017 fu creata Tallurutiup Imanga, l’area protetta più grande del Canada. Il regista Florian Leodux decise di intraprendere un viaggio dalla Groenlandia dell’ovest a Nunavut, per dar voce agli animali che vi abitano e alla loro vita, proprio per descrivere in un attimo il perché esistano le zone di protezione e spingere gli uomini a creare sempre nuove riserve. Ricordo una frase in questo momento, che reputo descriva quest’opera meglio di qualsiasi analisi io possa fare: “lascia che la vita che ti gira intorno, ti attraversi l’anima”.
Avevo visto in prima assoluta la proiezione di questo video …e per quanto possa affascinare, rivederlo mi ha dato modo di comprendere quanto possa inoltre anche stupire!

Il secondo filmato ha inizio: il titolo è Namanu Rruni, Albatros Island, ambientato in Australia e specificatamente in un angolo di Tasmania. Si tratta di un documentario di 14 minuti con regia di Mattew Newton. La voce narrante della biologa e ricercatrice Rachael Alderman, illustra la vita degli albatros in una delle sole tre isole al mondo in cui essi si riproducono. La sua esperienza personale di continuo censimento e osservazione, e i tentativi di tracciatura degli uccelli nelle loro rotte, creano una sinergia in cui lo spettatore vive esattamente ciò che la scienziata sta provando. Mentre le immagini scorrono il fruitore impara, frame per frame, la straordinaria profondità di quest’esistenza dalle grandi ali, senza poterne ignorare il carattere. Lo spettatore si trova a “essere la dottoressa Alderman” e inizia a esprimere pareri inconsci e spontanei, sull’adozione e la motivazione dei censimenti e sul come possano venire eseguiti: avranno senso? È proprio necessario mettere un braccialetto metallico alle caviglie di questi spiriti liberi? Servirà per proteggere la specie? Cosa si proverà a stare tanto tempo sull’isola? A camminare fra gli albatross? A vivere in una grotta?
Lo screenplay è semplice ma efficace e la regia strizza l’occhio ai paralleli empatici, paragonando l’età degli albatros a quella di Rachael e chiunque in sala effettua un paragone con la propria, ancora una volta entrando nel documentario come parte di esso. Quando l’opera finisce, con leggerezza il fruitore spicca il volo, lascia alle sue spalle l’isola, e si dirige verso nuove avventure.

…Ed esse arrivano in un attimo grazie ad Adventure is Calling, un film ambientato negli Stati Uniti della durata di 5 minuti, grazie alla regia di Lee Burghard. Che lo spettatore sia uno scuba o meno, cioè che si immerga con le bombole oppure prediliga lo snorkel o la semplice curiosità del guardare, non è possibile non rimanere a bocca aperta con questa incredibile meraviglia.
Normalmente mi dilungo su analisi e controanalisi nelle recensioni che ho la fortuna di poter comporre, ma in questo caso vorrei solo soffermarmi su un pensiero. Vorrei citare il film Don Juan De Marco: “Ci sono solo quattro domande che contano nella vita, Don Octavio. Cosa è sacro? Di cosa è fatto lo spirito? Per cosa vale la pena vivere? E per cosa vale la pena morire? La risposta a ognuna è la stessa”. Penso che si trovi facilmente in quest’opera quella risposta.
Veramente un piccolo capolarovo: e poi finalmente si parla di scuba diving!

L’unico limite di quest’ultimo documentario è forse la brevità. Proviamo a dargli durata, una trama, e mettiamoci dentro una storia d’amore e di sorrisi. Manry at Sea (Special tour edit) è il risultato. Il regista Steve Wystrach in 47 minuti, che volano come se fossero 5, racconta la storia di Robert Manry, che nel 1965 decise di abbandonare temporaneamente il suo lavoro di copy editor in una piccola azienda di Cleveland nell’Ohio, per inseguire i propri sogni e attraversare l’oceano dagli Stati Uniti all’Inghilterra.
La sua voce racconta l’assuefazione alienante che la vita standardizzata può avere, soprattutto la sua apaticità decostruente, che pian piano spegne i sogni finché essi stessi non spariscono. Penso a sir Anthony Hopkins quando paragonava i gorilla in gabbia a ombre di ciò che erano, creature potenti che non ricordano più la libertà, come se essa stessa non fosse mai esistita, come se loro l’avessero soltanto sognata. Penso a Tim Robbins che in una celebre battuta cinematografica affermò “o fai di tutto per vivere o fai di tutto per morire. Io ho scelto di vivere”.
Parrebbe il preludio di un film eroico ed epico, ma il sorriso di Robert è la variabile che scombina l’algoritmo. Parte con la barca più piccola che si sia mai vista, altro che il Pourquoi-Pas? di Jean-Baptiste Charcot o delle galee Allegranza e Sant’Antonio dei fratelli Vivaldi.
Qual è il diritto di una scintilla? Lo stesso che avverte Manry con il suo richiamo del mare che lo porterà a vivere grandiose avventure, a diventare una star, a godere di tutta una vita in pochi mesi. Il mix fra le riprese è dinamico e fornisce i punti di vista di tutti coloro che entrano in contatto con il protagonista, nonostante la lente sia sempre la sua: questo espediente porta il fruitore sulla piccola imbarcazione per tutto il tempo del viaggio, fino a quando finalmente egli può scendere, provando insieme a Robert il timore per il non utilizzo delle proprie gambe. Solo in un caso il caleidoscopio cambia: la barca viene intercettata e un cameraman vuole salire a bordo della stessa con una cinepresa da 30 kg; egli si rende conto che anche solo mettervi piede è un pericolo perché se cadesse in acqua, morirebbe all’istante affogato.
Questa è la cartina tornasole, la scala dell’impresa, a partire dal livello dell’orizzonte che inizia a variare all’istante con un rollio che dà il volta stomaco in pochi secondi. Manry è partito sulla sua nave e non può più scendere dalla stessa, e riesce a governarla attraverso gli oceani, con facilità e con il sorriso più spontaneo che esista, mentre il resto del mondo, non riesce nemmeno a salirvi! Se la storia ha un lieto fine, il suo epilogo è funesto, e non mi soffermo sullo stesso perché “guai allo spoiler”. Posso però dire che se lo storyboard è un esempio di cinematografia, il suo scioglimento è quantomai drastico, senza una dissolvenza anche solo metaforica che auguri nuove avventure o una morale: si tratta di una ghigliottina che non lascia posto purtroppo, nemmeno a qualche secondo di necessario amaro.

Se Manry at Sea era poesia epica, Forever è pura arte pittorica. Il filmato ambientato in Gran Bretagna, della durata di 2 minuti, opera dell’artista Tony Plant, è un picclo gioiello che compone creatività su una tela, grazie alla risacca, le maree e un grande time lapse. Il pittore ha dovuto attendere ben 4 anni per trovare le giuste condizioni climatiche di bassa marea in un lido della Cornovaglia. Tony è impegnato nella ricerca continua di un grande disegno sulla sabbia, tra giochi di ombre e di luci, mentre un mare noncurante lo cancella continuamente. Non si può non pensare ai mandala nepalesi e alla caducità della vita: si viene però distratti dallo spirito dei flutti che appare briccone e scherzoso, quasi che l’opera fosse un cartone animato di Hanna e Barbera, con la sfida tra Willy il Coyote e il road runner o forse l’eterna lotta tra Tom e Jerry, amici o nemici? Forever è la vita stessa, sostanzialmente rappresenta la nostra visione del mondo, costituita da un mare magnanimo che gioca con un suo piccolo figlio sorridendo di vita, regalandogli tutta l’esistenza possibile, perché nulla è per sempre; è infatti il protagonista che s’imbroncia con il mare briccone che proprio non la vuole smettere di dargli filo da torcere, senza rendersi conto che quella lotta non avrà luogo per sempre…

Surface è forse ciò che richiama di più al vero infinito, una lente verso un’altra dimensione, quello sguardo del mare che noi non riusciamo mai a vedere. L’opera ambientata negli Stati Uniti con regia di John Rodosky e Roam Media, della durata di 7 minuti, parte dalla vita di Ben Thouard, voce narrante alla ricerca di un nuovo modo di raccontare le sue immagini. Il fotografo nato nell’ambito del surf, effettua una ricerca, sia interiore, sia materiale, che in un anno lo porta a fotografare dall’interno delle onde, immerso dietro i frangenti, per cogliere l’attimo in cui essi ripiegano, un’istante prima della comparsa del tubo, frammento nel quale è possibile vedere attraverso gli stessi. Ciò che sostanzialmente Ben riesce a fare è vedere attraverso gli occhi di Nettuno, utilizzando una tecnica fotografica veramente all’apice di ciò che qualsiasi professionista possa immaginare.
Forse il film più bello?

Come rappresentare il mare stesso? Se questo fosse lo scopo o tendenzialmente tale? Ci prova Emocean (Special tour edit) con la regia di Tony Harrington in 22 minuti di opera ambientata in Australia. Se esiste una prova di grande passione essa è contenuta da questo insieme di lettere d’amore per il grande fratello blu. Il film racconta una serie di storie, alcune con un lieto fine, altre drammatiche, tutte totalmente impregnate da una passione senza limiti. La fotografia è mediamente piacevole, anche se fortemente colpita dal paragone che non si può non fare spontaneamente con il vicino Surface. Lo storytelling è dinamico con colpi di scena veramente notevoli, che non svelo perché il film è nelle sale, e che vengono supportati da un ottimo screenplay specifico, contenuto all’interno di ogni singolo capitolo.
Non posso fare a meno di notare anche che, nonostante tutte queste belle premesse, l’opera risulta carente rispetto alle altre, sotto svariati punti di vista. Lo spettatore spesso si chiede se si stia osservando ancora lo stesso filmato o se sia cambiato senza notarlo… anche la morale complessiva è un carillon avvertito molte e molte volte da opere molto più altisonanti. Probabilmente questa sensazione mediamente condivisa, è però spinta anche dal semplice fatto che raccontare un film composto da piccoli filmati in un festival composto da vari filmati, è sicuramente un’impresa molto ardua!

Molto specifico e decisamente d’impatto è invece Southern Right Whale (special tour edit), filmato ambientato in Argentina, nel cuore acquatico del mare di Patagonia. L’opera dura 18 minuti ed è sapientemente condotta dalla regia di Kevin Zaouali, che dipinge la vita inseguendo le abitudini della balena Franca, Eubalaena australis secondo la classificazione di Desmoulins del 1822, cacciata per due secoli e protetta dal 1937.
Questa “pellicola” è un vero “inno alla vita raccontato magistralmente attraverso una magica e poetica combinazione di immagini, musica e parole”. Non so se possa affermare, anche solo a mio personale parere, che questo sia o meno il filmato più bello, ma credo di poter dire tranquillamente che il biglietto dell’Ocean Film Festival vale anche solo per la visione di quest’opera.

La serata si conclude con il divertente e spettacolare Surfer Dan, ambientato negli Stati Uniti, nel lago superiore del Michigan, durante il congelamento invernale. 7 minuti scanzonati e simpatici, con regia di Tim Kemple, che portano un messaggio attraverso il “gioco” del surfer Dan che tenta di vivere la sua passione fra i ghiacci, tra i frangenti che rompono una sorta di pack.
L’avventura è ovunque e in qualsiasi momento, non termina mai, e ogni volta che usiamo un “se” o un “ma” non descriviamo limiti oggettivi, ma soltanto la nostra pigrizia nell’aprire gli occhi e fare il primo passo. Lo scherzoso protagonista dimostra che alla persona media che non subisce i drammi della nostra epoca, per vivere l’avventura non servono soldi, grandi progetti, architetture, fortuna e combinazioni, basta semplicemente vivere! Mentre c’è chi spreca il tempo a commiserarsi esiste un semplice trucco segreto, di cui praticamente chiunque è a conoscenza: cosa serve per vivere un’esistenza incredibile ogni istante del proprio cammino? Farlo.

I titoli di coda scorrono e io penso al festival nel suo insieme. Mi e piaciuto moltissimo e ho potuto davvero rilassarmi per qualche ora. Da un lato mi è mancata molto l’avventura in senso diretto, la classica storia raccontata con gli occhi di un protagonista in prima persona che prepara un’avventura verso il limite e tenta di raggiungere il suo sogno. Ho in compenso avuto la rappresentazione della meraviglia da ogni angolazione possibile. Il taglio documentaristico ha accresciuto il mio piccolo sapere e di certo non ha limitato la mia curiosità!
Le luci si accendono di nuovo …e anche quest’anno l’Ocean lascia spazio alla vita.
Ho voglia di mangiare un panino con i miei amici e progettare di fronte a una birra la prossima immersione, la prossima scalata, la prossima piccola o grande esperienza appassionata …perché questo è l’Ocean, lo stupore negli occhi del bimbo che rimane con noi.
Christian Roccati
Follow me on FACEBOOK – Instagram