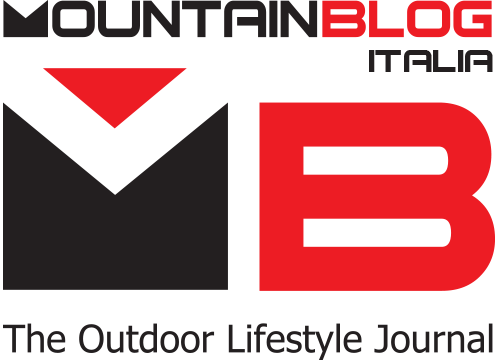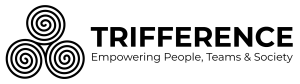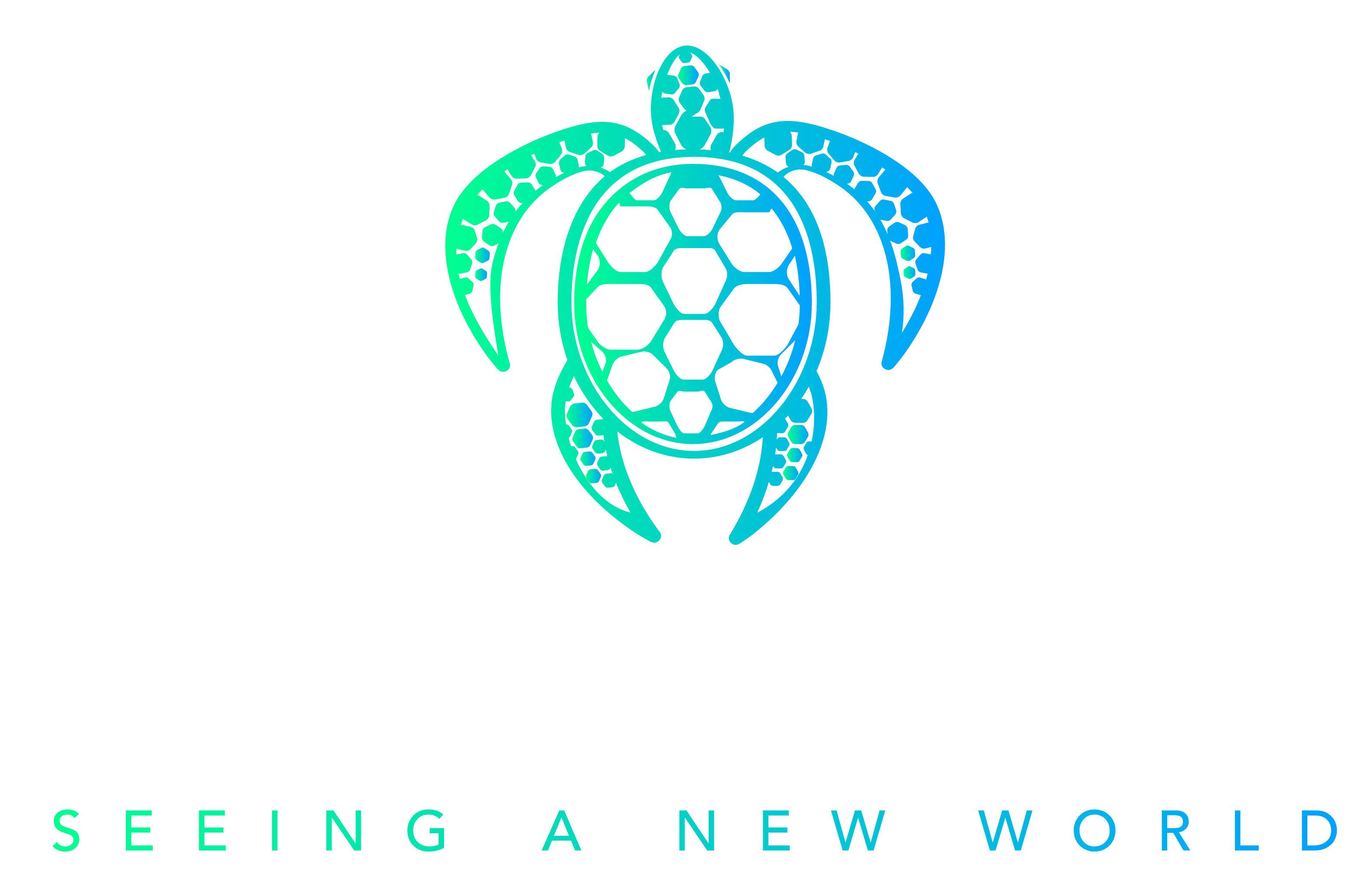Un po’ di anni fa andai a trovare il grande e illustre poeta Andrea Zanzotto e, tra un pasticcino e l’altro, tra un ricordo e una riflessione sullo stato del paesaggio veneto, lui rievocò sconsolato una delle sue massime: “Un tempo c’erano i campi di sterminio, oggi assistiamo allo sterminio dei campi”.
A distanza di tempo queste parole sono tornate a farmi visita in una mattina autunnale mentre dalla Borgata Mori, in Valbrenta, salivo verso il Sasso Rosso. A due passi, il suono delle rapide del Brenta si confondeva con il frastuono provocato dagli escavatori, dalle perforatrici, dai bulldozer, dai frantumatori e dagli autocarri operanti nella cava di Costa Alta, proprio dall’altra parte del fiume. All’insopportabile rumore si aggiungeva la spietata visione di una ferita aperta nella montagna. Non c’era il colore del sangue a impietosire e indignare, ma un laconico bianco che sembrava scalinare dal basso all’alto quel segmento di terra che un tempo vestiva di natura selvaggia.
Salivo verso l’alto buttando continuamente l’occhio verso destra e, ogni volta, quella spaccatura, quello smembramento, mi ferivano l’animo. Sì, mi dicevo, Costa Alta sarà solo una piccola e sconosciuta montagna alle pendici occidentali del Massiccio del Grappa, di appena 634 metri, ignorata da passanti ed escursionisti, ma pur sempre parte di un grande insieme che conforma quel massiccio. E ora non c’è più.

Ma a chi può interessare se le si porta via un pezzo di verde, un po’ di vegetazione, se la si lascia nuda alle intemperie, alla berlina, alla mercé del profitto? Vuoi mettere quanto rende! Lì, nella cava di Carpanè, si estrae la dolomite (doppio carbonato di calcio e magnesio) che, a quanto sappiamo, viene utilizzata in agricoltura, nella zootecnia, nell’industria alimentare e nell’edilizia. Utile, si direbbe. Non c’è dubbio — ma a che prezzo?
Salivo sperando che i passi mi portassero al più presto più in alto, più lontano da quel frastuono e da quella visione, ma poi sentii un’esplosione. Mi girai e vidi una grande nube bianca che avvolgeva il Canal di Brenta; la polvere scendeva e, trasportata dal vento, si adagiava anche sui tetti dall’altra parte del fiume. Lì non c’erano i campi di cui parlava il poeta, almeno non nel senso letterario, eppure anche in quella piccola porzione di montagna una terra con tante vite veniva spazzata via, sterminata.
Guadagnavo quota verso ovest, tra un paesaggio fatto di terrazzamenti e muretti a secco, mentre a est, oltre il Brenta, l’impervio scenario del versante mostrava lo scempio di una montagna sventrata, ridotta all’osso da pale e perforatrici. Mi catturava lo sguardo, ma non per ammirazione: per offesa. Per perdita.

Ero lì per cercare natura e bellezza lontano dalla città, e camminavo tra terrazzamenti e muretti a secco — “masiere” — costruiti con tale maestria, con tanto sudore e immani fatiche, da commuovere (per farsi un’idea di come siano stati costruiti si guardi Fazzoletti di terra del documentarista Giuseppe Taffarel). Lì passava anche la famosa Alta Via del Tabacco (32 km, 2400 metri di dislivello), che dal Ponte Vecchio di Bassano del Grappa giungeva fino alla località Costa di Valstagna: un tempo via di comunicazione tra borgate e terrazzamenti per la coltivazione e il contrabbando del tabacco, oggi percorso escursionistico molto gettonato.
Com’era possibile questa dicotomia? Da una parte l’equilibrio, l’armonia, il segno di chi aveva usato il paesaggio senza sfruttarlo né deturparlo, anzi rendendolo gradevole alla vista; dall’altra lo sfregio, la violenza, l’abuso, l’obbrobrio che non ammette replica. Per un istante mi parve di essere nelle Alpi Apuane, dove ovunque si giri lo sguardo si incontra una cava di marmo.
Per tutta la salita fui accompagnato da un tormento che non mi diede pace. Continuavo a domandarmi perché continuiamo a distruggere e, allo stesso tempo, a cercare luoghi belli dove camminare e immergerci nella natura in cerca di bellezza.
Il mio percorso prevedeva un giro ad anello e, al ritorno, camminai un buon tratto dell’Alta Via del Tabacco, sempre con la cava in vista. Mentre scendevo un sentiero ben scalinato e lastricato, vidi salire una, due, tre, poi un’altra dozzina di ragazzi, non proprio vestiti da escursionisti: sembravano normali cittadini.

«Ciao, che gruppo siete?» chiesi alla terza faccia che mi passò davanti.
Il ragazzo ansimava ed era sudato; si vedeva che la salita lo metteva alla prova.
«Siamo un gruppo di studenti universitari» rispose, continuando a seguire quello che, da capofila, doveva essere il giovane docente.
«Cosa studiate?» domandai a un’altra ragazza.
«Scienze del paesaggio. Siamo venuti a studiare i muretti a secco, i terrazzamenti» disse, fermandosi a prendere fiato.
«Avete visto che meraviglia questi giardini? Che perfezione, che arte! Altro che quella bruttura» dissi, attirando la loro attenzione e volgendo lo sguardo verso la cava.
«Eh sì, non c’è paragone» replicò la ragazza.
«Ma i tempi sono cambiati, e oggi non si potrebbe vivere di solo tabacco e paesaggio» aggiunse un suo compagno, passandomi accanto ansimante.
«Del tabacco possiamo fare anche a meno, ma del paesaggio no: è il nostro respiro, il nostro orizzonte, la nostra terra e le nostre radici. Dovreste essere voi i futuri paladini del paesaggio. Non vi pare?»
«A me basta arrivare dove dobbiamo arrivare. Non pensavo ci fosse così tanto da camminare» ribatté, un po’ seccato, il ragazzo con i baffetti.
Capii che mi conveniva proseguire la discesa e lasciare la comitiva salire, sperando che poi potessero traguardare il paesaggio e vederci qualcosa d’altro.
Qualche centinaio di metri più in basso incrociai altre tre ragazze che, a vederle, sembravano uscite da un bar di città: una indossava un lungo cappotto e stivali in cuoio.
«Scusi, sono molto lontani gli altri?» mi chiese quella dalla fisionomia cinese.
«No. Ma dove siete dirette?»
«Non lo sappiamo nemmeno noi. Il prof ci aveva parlato di una breve salita per vedere edifici e terrazzamenti lungo la Via del Tabacco, ma questa è una scarpinata che non finisce mai» rispose quella con gli occhiali.
«E pensate che qui la gente ci viveva, e tutti i giorni faceva su e giù con grandi pesi sulle spalle; non dovreste lamentarvi» dissi con un sorriso ironico.
«Mica siamo gente di montagna noi. Siamo qui solo per studiare il paesaggio, perché è materia di studio, e il prof ha detto che qui c’è tanto da imparare» replicò lei.
«Ecco, tu l’hai detto: guardatevi attorno e cercate di imparare…».

Perché siamo al di qua delle alpi
su questa piccola balza
perché siamo cresciuti tra l’erba di novembre
ci scalda il sole sulla porta
mamma e figlio sulla porta
noi con gli occhi che il gelo ha consacrati
a vedere tanta luce ed erba.
Sì, Andrea, il poeta, aveva proprio ragione: dovremmo essere inclini al bello, vocati a vedere tanta erba e luce, per non perdere mai lo stupore negli occhi e nell’anima.