MORIRE IN MONTAGNA. UN CONTRIBUTO DI ORESTE FORNO
L’alpinista Oreste Forno, ha scritto questo contributo dopo la morte di Marco Anghileri. Ve lo proponiamo come spunto di riflessione in concomitanza della celebrazione pasquale, che – nel suo significato cristiano – indica il passaggio dalla morte alla vita.

“Cari amici,
di fronte al dolore causato dall’ennesima tragedia che nei giorni scorsi ha avuto come teatro il Pilone Centrale del Freney, nel Gruppo del Monte Bianco, ho sentito un rabbioso bisogno di alzare ancora di più la voce. Sarà che di dolore ne ho già visto troppo, sarà che non concepisco più che un ambiente dove si va per Vivere con la V maiuscola diventi troppo spesso terreno di morte. Per questo ho scritto queste riflessioni che desidero condividere con tutti voi, con la speranza di poter iniziare insieme un percorso che potrebbe finalmente portare a risvolti positivi. Vi chiedo quindi di seguirmi e di riflettere su quanto vi dirò, perché saranno le vostre idee e osservazioni a dare maggior forza a questo intento. Se saremo in tanti, credo che faremo veramente un buon lavoro.
MONTAGNA COME MEZZO
Comincerò col dire che la montagna è qualcosa di meraviglioso, di cui ci si può anche innamorare. Ma, attenzione! Ci si può innamorare di una montagna come ci si può innamorare di una bicicletta, di un paio di sci, di una macchina fotografica…
Perché credo che la montagna sia anzitutto un mezzo. Un mezzo che permette all’uomo di soddisfare certi suoi bisogni.
Bisogno di avventura.
Bisogno di lotta che l’uomo si porta dentro fin dalle origini.
Bisogno di libertà che tanto manca nella vita odierna.
Bisogno di evasione, di pace e di silenzio. Di rilassamento. Di bellezza e di emozioni.
Bisogno di ricerca per dare un senso alla propria vita. Ricerca del Sublime, della spiritualità.
O, ancora, bisogno di autostima.
Oppure, di migliorarsi, di innalzare i propri limiti, di superare gli altri con il rischio di cadere nell’ambizione!
L’ambizione è una caratteristica che troviamo nella stragrande maggioranza degli alpinisti e non necessariamente va vista come un male, perché è il motore che fa crescere le cose, che innalza i limiti, che porta in alto. Nell’alpinismo come nello sport, nel lavoro, nella ricerca scientifica e tecnologica, nell’arte, nella politica. Persino in campo sociale, credo. La differenza sta nel fatto che nell’alpinismo può arrecare gravi danni, perché chiedendo troppo si corrono dei rischi che possono essere causa di morte. È quello che succede, purtroppo abbastanza spesso.
Si va quindi in montagna in cerca di benefici e a volte si muore. Come dire che la montagna che tanto da’, qualche volta prende. Ma forse possiamo chiederle di prendere di meno.
CHI MUORE?
Anche chi non è ambizioso. I meno esperti quanto i più forti e preparati. Ci passiamo tutti.
Gli escursionisti che si trovano ad affrontare difficoltà alle quali non sono preparati. Come camminare in inverno su un sentiero percorso senza problemi nel corso dell’estate. O quelli che non sono in grado di far fronte a un repentino cambiamento del tempo, o che non sanno valutare un pericolo che normalmente esula dal loro mondo. È già successo che escursionisti siano morti per scivolata su un sentiero ghiacciato, come per assideramento. Ed è di questi giorni (marzo 2014) l’incidente sul Palanzone (Alto Lario), con la valanga che ha travolto tre escursionisti mentre camminavano tranquillamente sulla strada poco oltre il rifugio Riella. Una valanga sul Palanzone? Sembra incredibile, ma è vero. Salvate una donna (con una gamba fratturata) e una bambina di quattro anni, perché emergevano ancora dalla massa nevosa. È andata peggio per il nonno della bambina, di 62 anni, deceduto per le conseguenze qualche giorno dopo.
Gli alpinisti poco esperti che si fanno cogliere impreparati su una via. Quando per esempio ci si trova di fronte a difficoltà diverse da quelle abituali, magari portate dal cattivo tempo, o da variate condizioni del percorso.
Gli alpinisti che si spingono troppo oltre i propri limiti. È giusto cercare di migliorare i propri limiti, fa parte della natura umana, ma bisognerebbe farlo con maggiore sicurezza. Per esempio con il supporto di una persona adatta al caso, di una guida.
Gli alpinisti che non sanno rinunciare di fronte all’insorgere di difficoltà impreviste. Quelli che dicono “Ormai siamo qui, dopo tutte queste ore di macchina, e quando ci si ripresenta un’occasione come questa?
Gli alpinisti della cima a tutti i costi.
Gli alpinisti esperti e forti in seguito a troppa confidenza, o per un breve abbassamento della guardia. Muoiono anche questi. Il mio caro amico Giuliano De Marchi, senza il quale oggi non sarei qui a scrivere queste riflessioni, e al quale altri alpinisti devono la vita, dopo tante spedizioni sulle montagne più dure dell’Himalaya è morto sull’Antelao, una montagna di casa che conosceva come le sue tasche, durante una semplice salita con gli sci. Graziano Maffei, per fare un altro esempio, fortissimo arrampicatore delle Dolomiti, è morto cadendo in un crepaccio in cima alla Marmolada, al termine dell’impegnativa scalata della via “Don Chisciotte”, sulla verticale parete sud. Anche Renato Casarotto è morto in un crepaccio, sul K2, dopo essere sceso dal difficile sperone sud ovest, sul quale era stato impegnato per giorni. E andando ancora indietro possiamo arrivare fino a un altro grande personaggio, Emilio Comici, morto durante una banale arrampicata in Vallunga (Valgardena).
Gli alpinisti coscienziosi vittima dell’imponderabile. Hermann Buhl, per esempio, è precipitato sul Chogolisa in seguito al cedimento di una cornice. Una condizione impossibile da valutare per la tormenta e quindi la troppa scarsa visibilità di quel momento. Carlo Pedroni è morto per una pietra che l’ha colpito in fronte, nonostante il casco, durante una scalata sul Pizzo Badile. Cosimo Zappelli, guida alpina valdostana, è morto nel Gruppo del Monte Bianco per una scarica di sassi impossibile da prevedere. Paolo Cavagnetto, istruttore ai corsi guida, è caduto sulla Tour Noire del Monte Bianco con due allievi, probabilmente per il distacco di una parte di roccia, o di un masso, con il chiodo del rinvio. Mario Merelli, grande nome dell’Himalaya, è morto a pochi passi dalla vetta dello Scais, una montagna di casa sua, per un masso instabile che gli ha fatto perdere l’equilibrio. E potrei dilungarmi oltre…
Gli alpinisti ai vertici che per rimanere sul podio guadagnato duramente, o magari per salire ancora di un gradino, sono costretti a buttarsi su difficoltà sempre più elevate. Mi vengono in mente Jerzy Kukuczka, caduto sulla Sud del Lhotse, Miroslav Sveticik (Slavko), tra i miei alpinisti alla Ovest del Makalu, morto durante una scalata in solitaria sul Gasherbrum IV. Conservo la cartolina che mi aveva mandato da quella spedizione, dove diceva “SOLO”. Thomaz Humar, morto sul Langtang Lirung. Potrei fare altri nomi, ma credo che bastino questi esempi.
DOVE SI MUORE DI PIU’?
Vediamo piuttosto dove si muore di più. Facendo le dovute proporzioni, numero dei morti in base al numero degli alpinisti, dove si muore di più è sicuramente sulle grandi montagne dell’Himalaya e del Karakorum, dove l’ambiente è più duro e difficile da interpretare. Lì si parla di vere ecatombe, come nel 1937 sul Nanga Parbat, al campo IV, dove un’intera squadra composta da 7 alpinisti e 9 portatori d’alta quota fu cancellata da una valanga di ghiaccio. O sul Manaslu nel’73, quando 16 persone di una spedizione coreana (5 alpinisti e 11 sherpa) furono uccise da una valanga. O sul K2 nel 1986, dove morirono ben 13 persone appartenenti a spedizioni diverse, o sull’Everest quando nel solo mese di maggio del 1996 perirono 5 persone di due spedizioni commerciali, dopo più di 150 morti dovuti anche al grande richiamo esercitato dalla montagna più alta della terra. Per rendersi conto ancora meglio, basta pensare a una statistica spagnola stilata 15 anni fa che parlava già di 600 morti tra Himalaya e Karakorum, e da allora quanti ce ne sono ancora stati? Credo che sia ancora nelle nostre menti la tragedia del Manaslu di soli due anni fa, quando 11 persone furono uccise in un colpo solo da una valanga, e altre scamparono per miracolo!
PERCHE’ SI MUORE DI PIU’ SULLE GRANDI MONTAGNE?
Per i problemi legati all’alta quota. La carenza di ossigeno e ciò che ne consegue, come la possibilità di edema polmonare e cerebrale, l’affaticamento o la diminuita lucidità mentale.
Per le condizioni ambientali molto severe. Come il freddo che porta i congelamenti. Quanti ce ne sono stati! O il vento fortissimo che ti distrugge le tende. O la tormenta che ti taglia completamente le gambe. In un ambiente tanto vasto non sai più dove sei e tanto meno dove puoi finire.
Per l’alta esposizione. Una spedizione a un Ottomila può durare anche mesi, fatti di continui saliscendi.
Per la difficoltà a decifrare le condizioni di pericolo. Gli incidenti maggiori sono stati causati da valanghe che hanno spazzato via campi interi. Del resto non è facile capire cosa c’è sopra finché non ci arrivi.
Per non sapere dire di no di fronte a un rischio troppo alto. Per arrivare in cima all’Annapurna bisogna attraversare un tratto di pendio in cui è facile essere soggetti a un vero tiro al bersaglio, a causa dei seracchi soprastanti che scaricano in continuazione. Ma quando sei lì, a un passo dalla vetta, e ci sei arrivato dopo settimane di duro lavoro, e pensi che un’altra volta non ci torni più, diventa difficile rinunciare. Non per niente l’Annapurna è la montagna che percentualmente ha più morti, anche più dell’Everest e del K2, e la già citata statistica spagnola dovrebbe far drizzare i capelli quando dice che il 53% di coloro che vi si sono cimentati non sono tornati. Eppure c’è chi continua ad andarci perché la sua salita è indispensabile per completare la serie dei 14 Ottomila.
Per il peso dello sponsor? Molti lo pensano, ma probabilmente questo capita, o può capitare, solo con alpinisti professionisti che con le spedizioni cercano di portarsi a casa lauti profitti.
COSA SIGNIFICA MORIRE?
Fino a questo punto non ho detto niente di nuovo, cose che sicuramente sapevamo già. Però quanti si sono mai chiesti veramente che cosa significhi morire in montagna, a una giovane, o relativamente giovane età? Provo a spiegarlo con un esempio che mi riguarda.
Il 10 maggio 1985, verso le dieci del mattino, caddi in un crepaccio. Ero al mio primo tentativo di un 8000, lo Shisha Pangma. Quel giorno eravamo partiti in tre dal campo base avanzato, con l’intento di andare fino in cima. Ci accompagnava una quarta persona che si sarebbe però fermata al campo 2, a 7000 metri, installato nel corso delle salite precedenti.
Quando caddi ero abbondantemente in testa, perciò nessuno mi vide. Ero precipitato per quasi 30 metri, ed è difficile sopravvivere a un volo così. Anche perché prima che scoprissero l’accaduto e mi tirassero fuori passarono due ore. Due ore all’interno del crepaccio, mezzo rotto. Qualcuno disse che quel giorno nacqui una seconda volta. Si vede che non era la mia ora.
Avevo 34 anni. Fino a quel momento avevo avuto una vita bella e interessante, grazie anche al lavoro che mi aveva permesso lunghi soggiorni negli Stati Uniti e che continuava a darmi modo di viaggiare. Ma quanto avrei perso se fossi morto in quel crepaccio? Ci ho pensato tante volte. Avrei perso la seconda parte della mia vita, quella che mi ha dato le cose più importanti. Come unirmi a una donna per dare il dono della vita ai miei due figli, che valgono ben più di qualunque cima avessi mai potuto fare! Chi ha figli sono certo che capisce… O scrivere quei libri con i quali credo di aver saputo trasmettere qualcosa! O andare da un posto all’altro con le conferenze che mi hanno portato tanti amici e aperto orizzonti nuovi! O aver potuto dare un po’ di aiuto a qualcuno fra i tanti bambini poveri del mondo… Fare un po’ di bene…
Ecco, allora, cosa avrei perso se fossi morto quel 10 maggio di trent’anni fa! Avrei sfruttato meno della metà il grande dono, unico e irripetibile che mi era stato dato. E sarebbe stato un vero peccato perché l’opportunità della vita, l’occasione più grande in assoluto, si presenta una volta sola.
Ma morire non significa solo questo. Se fossi morto, mio padre, già anziano e malandato, probabilmente non avrebbe retto e sarebbe morto di crepacuore (mia madre ci aveva già lasciati anni prima). Morire significa anche gettare nel dolore più atroce, se non nella disperazione, le persone che ci amano di più.
La scena che mi è sempre rimasta impressa è quella del papà di Paolo Cavagnetto, caro compagno di spedizione al Lila Peak, nel giorno del suo funerale. Non l’avevo mai incontrato prima e me l’ero ritrovato davanti in chiesa, di spalle, in prima fila davanti a me che stavo nella seconda. Ricordo come fosse adesso. Era in piedi, alto, con gli occhi sulla bara del figlio, sorretto dalle figlie che lo tenevano a braccetto, una di qua e l’altra di là. E sapevo che non molto tempo prima, un anno, forse due, aveva già perso l’altro figlio maschio, anche lui caduto nel Gruppo del Monte Bianco. Avevo davanti a me un padre che in montagna aveva perso entrambi i figli maschi, e mi chiedevo come sarebbe stato per lui continuare a vivere con un simile dolore… Ma ne ricordo altre. Ricordo bene quello che mi rispose la mamma di Battistino Bonali, quando per consolarla le dissi: “Tina, devi essere fiera di tuo figlio, è un eroe per tutti e guarda cos’ha portato la sua morte! Guarda quanto bene stanno facendo col suo nome quelli del Mato Grosso…” Rimanendo seria, mi rispose semplicemente: “Avrei preferito mio figlio con niente di tutto quello che ha fatto, ma qui, vivo.” Parole accompagnate da quel dolore silenzioso che ritrovai ancora in più occasioni. Parlando con la mamma di Lorenzo Mazzoleni, morto sul K2. Con i genitori di Paolo Crippa, morto con Eliana De Zordo sulla Torre Egger, in Patagonia. Con la mamma di Alessandro Chemelli, morto a 23 sul Canalone Gervasutti, al Mont Blanc du Tacul, insieme a Dario Bampi. “Comprendo appieno il detto ‘si muore per crepacuore’ – mi aveva scritto -, e se c’è un Dio che mi ascolta chiedo a Lui, per la prima volta, che mi siano risparmiate altre sofferenze, almeno per il momento, perché non avrei la forza di sopportare”. E con genitori ancora, mogli, fratelli, sorelle, amici, che contattai quando iniziai ad alzare la voce contro la morte in montagna, quando scrissi il libro “Il paradiso può aspettare. Ma non ho mai parlato con bambini, con i giovani figli che hanno perso il loro papà in montagna. Non l’ho mai fatto, ma vedendo l’amore che i miei figli provano per me posso ben immaginare il loro strazio. E che dire del fatto che nel loro futuro non ci sarà più un riferimento così importante? Con questo non voglio criticare le scelte di chi poi in montagna ha perso la vita, non posso e nemmeno ne ho il diritto. Espongo però le conseguenze.
LA MORTE, UN PREZZO DA ACCETTARE?
Di fronte alla morte, più di una volta mi sono sentito dire: “Fa parte dell’andare in montagna e bisogna accettarla per i tanti benefici che comunque la montagna dà.”. E pensando alle tantissime persone che trovano grande soddisfazione e gioia nell’andare in montagna, come si fa a non condividere un’affermazione come questa? Ma la questione è un’altra, perché non si tratta di togliere l’uomo dalla montagna, o viceversa, perché a quel punto bisognerebbe toglierlo anche dalla strada, e l’uomo non è fatto per stare sotto una campana di vetro. E nemmeno gli si può vietare la montagna più dura. Lo dico perché so cosa significhi sentire quel bisogno, che è come una luce che ti acceca, ma che allo stesso tempo ti permette di vivere momenti ed esperienze che rendono più ricca la tua vita. E allora credo che si possa anche accettare la possibilità di morire in montagna, se questo avviene in modo del tutto accidentale e non per negligenza, o per errore, o presunzione, o per troppa pienezza di sé, purché si faccia comunque il possibile per scongiurarla. Quindi mettiamola così: LA ‘PELLE’ A TUTTI I COSTI, E NON LA CIMA A TUTTI I COSTI!
EVITARLA PER SE STESSI
Nel momento in cui mi metto in autostrada so di correre dei rischi. Ma un conto è se vado a 120 all’ora, un altro se tiro la macchina a 200. Un altro ancora se a ogni occasione insisto ad andare a 200 all’ora. Il problema è chiaro e la risposta semplice: basta tenere una velocità moderata per abbassare il rischio. Questo esempio può applicarsi anche alla montagna: il rischio può esserci anche su terreno facile, ma più vado sul difficile e più rischio; e se insisto a stare sul difficile rischio ancora di più. Però in montagna le cose non sono così semplici, perché le variabili sono molte, e se certi aspetti sono evidenti, altri, pur molto importanti, sfuggono alla nostra attenzione.
Uno di questi è la rimozione della morte, una caratteristica dell’alpinista che lo porta a nemmeno considerare il fatto di poter morire in montagna (parole di psicologi). Nemmeno quando è toccato da vicino, come con la morte di un compagno, e nemmeno all’evidenza che muoiono anche quelli più forti e preparati di lui. Eppure la morte è la nostra compagna della vita, ci accompagna dal giorno in cui siamo nati. Credo che aiuterebbe farcela amica e rivolgersi a lei nei momenti di pericolo per chiederle consiglio.
Un altro è quello che io chiamo ‘la montagna che sta dentro’. Se ci pensiamo bene, scalare fisicamente una montagna è anzitutto scalare la nostra montagna interiore, perché l’esigenza, il bisogno, viene da dentro. Quindi penso che ognuno abbia la propria montagna, più facile o difficile a seconda del proprio ‘Io’, che determina la scelta esterna. Ci sarà perciò chi è contento di una semplice escursione, chi di una salita un po’ più impegnativa, chi di una via di VI grado, o chi ha bisogno di una scalata all’adrenalina. Un fatto di fortuna o di sfortuna? Sì, perché trovi la pace quando raggiungi la tua cima, e quindi c’è chi ci arriva più facilmente e chi deve lottare duramente, facendo i conti anche con un ambiente ostile. Una strada senza via d’uscita, quindi? Sembrerebbe, ma l’esperienza personale mi dice che non è così, perché oltre alla scalata vera e propria ci sono altri mezzi che aiutano ad arrivare su questa cima. La mia cima fu piuttosto dura, ma non durissima, e la raggiunsi nel momento in cui non ebbi più bisogno delle sfide. Quando la luce accecante che prima mi attirava senza scampo verso l’alto iniziò ad affievolirsi. Gli altri mezzi furono l’arrivo dei figli, l’interesse e la passione crescente per la scrittura, la maturità che avanzava, certamente, con la maggior sicurezza in me stesso. Purtroppo anche la perdita di amici cari, caduti in montagna, e quella di tanti alpinisti forti che avevo conosciuto.
Non converrebbe, allora, prestare più attenzione a queste cose?
Un altro aspetto ancora, facile da ignorare, è la spinta che viene dal basso, dalle persone che ci seguono, che sognano con le nostre imprese, che ti acclamano alla fine di una salita riservata a pochi, che ti battono le mani nelle conferenze; che fanno le ore piccole per seguirti in diretta su Internet. In altre parole, sono quelli che vedono in te un riferimento importante, e che nel momento della tua morte faranno di te un eroe. Magra consolazione. E allora bisognerebbe chiedersi quanto il pubblico condiziona, o determina, le nostre scelte. E al pubblico magari bisognerebbe chiedere di essere più obiettivo nel dire senza timore se uno sbaglia. Invece quando uno ha perso la vita per un errore, magari per aver tirato troppo la corda, la disapprovazione avviene solo con timidi sussurri. Forse per rispetto di chi è morto, forse per non ferir di più chi sta già soffrendo.
Ho parlato solo di alcuni aspetti che generalmente sfuggono alla nostra attenzione, ma ce ne sono altri. Cercarli tutti, noti e meno noti, e ragionarci a fondo ci aiuterà nelle nostre scelte.
AIUTARE GLI ALTRI A EVITARLA
Credo che molti alpinisti, soprattutto quelli rivolti ai traguardi più ambiziosi, nemmeno vogliano sentire parlare della morte. Forse anche per timore di veder vacillare il loro entusiasmo, le loro convinzioni. E allora dovremmo essere noi, un papà, una mamma, una moglie, un amico, un bambino, a frenare il loro impeto, la loro esuberanza. Ci vorrebbe un figlioletto che si presenta al suo papà dicendo: “Papà, se proprio devi andare vai, ma ricordati che ci sono anch’io, che non posso stare senza te.”. Sì, dobbiamo farlo, per tutti quelli che ci stanno a cuore, per il bene loro e per il nostro.
Pochi mesi fa è uscito il mio nuovo libro, “La farfalla sul ghiacciaio”. Sulla quarta di copertina c’è scritto: ‘Un libro per aiutare gli alpinisti a non morire. Un libro dove la montagna si fa vita.’ Spero veramente possa essere d’aiuto, ma spero anche di vedere nascere sempre più, pur tra libri che parlano di grandi imprese, quelli inneggianti alla bellezza della vita.
IL PIACERE DI UNA MONTAGNA DIVERSA
Quand’ero attratto dalle grandi sfide nemmeno mi accorgevo di questa montagna che scoprii più tardi, che mi trovai davanti come un dono quando raggiunsi la cima della mia montagna interiore.
Eppure sono in molti a conoscerla e a cercarla per goderne. È la montagna che ci attira per la sua bellezza. Che ci offre incredibili emozioni con gli splendidi scenari offerti dalle vette; con i colori dolci dell’aurora; con le albe che annunciano il nuovo giorno; con i tramonti che fanno del cielo un fuoco; con un fiore che ti ritrovi nel punto più impensato; con una sorgente d’acqua freschissima incontrata sul cammino; con un animale libero che lassù vive indisturbato, un’aquila che passa da una cima all’altra senza nemmeno un battito di ali. Con la luna che si alza a tenerci compagnia; con le stelle che brillano in un cielo nero…
È la montagna con il vento che ci scuote senza impensierirci; che ci sprona alla fatica e che poi ci fa apprezzare la stanchezza. Perché la stanchezza rilassa la mente e ci fa stare bene, aiutandoci il giorno dopo ad affrontare con più slancio una nuova giornata di lavoro, la vita quotidiana.
È la montagna che con il silenzio e la solitudine ci aiuta a guardarci dentro e a interrogarci. Che ci invita a staccarci dalla terra per trovare in alto una risposta ai perché di questa nostra vita. Che ci offre la speranza di Qualcosa che va oltre questa vita. E tutto questo, senza chiederci di rischiare, permettendoci di tornare ogni volta a casa per dividere la nostra gioia con chi ci vuole bene.
Com’io un tempo, credo che molti alpinisti non abbiano ancora gli occhi per questa montagna. E allora è bene dire loro che c’è, e che sarà lì ad aspettarli nel giorno in cui avranno raggiunto la loro cima. Farglielo sapere potrebbe aiutarli a condurre con più coscienza le loro sfide.
CONCLUSIONI
A spingermi a queste riflessioni era stato il pensiero di poter trovare il modo di aiutare chi va in montagna a non morire. Giunti a questo punto, credo di poter dire che la cosa migliore da fare, e forse l’unica, sia una sola: parlare della possibilità di morire in montagna, ma farlo in ogni momento, martellando se è il caso, senza attendere l’occasione. Perché se si aspetta l’occasione potrebbe essere troppo tardi per qualcuno. Credo che in questo scritto ci sia abbastanza materiale da poter incominciare. E siccome da cosa nasce cosa, penso che anche da voi arriveranno altri spunti, altre idee, che renderanno l’andare in montagna più sicuro.
Oreste Forno ([email protected])
Tags: Alpinismo e Spedizioni, Avventura, experience, Insight, Marco Anghileri, Morire in Montagna, morte in montagna, Oreste Forno, Pasqua, riflessioni, spiritualità
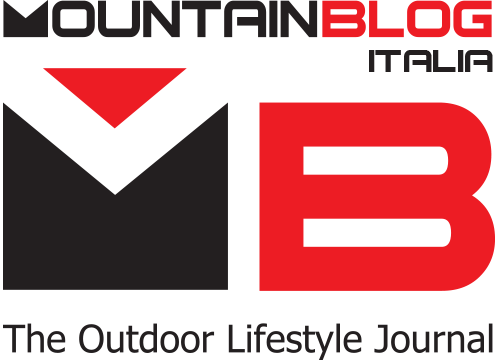
 Action
Action


























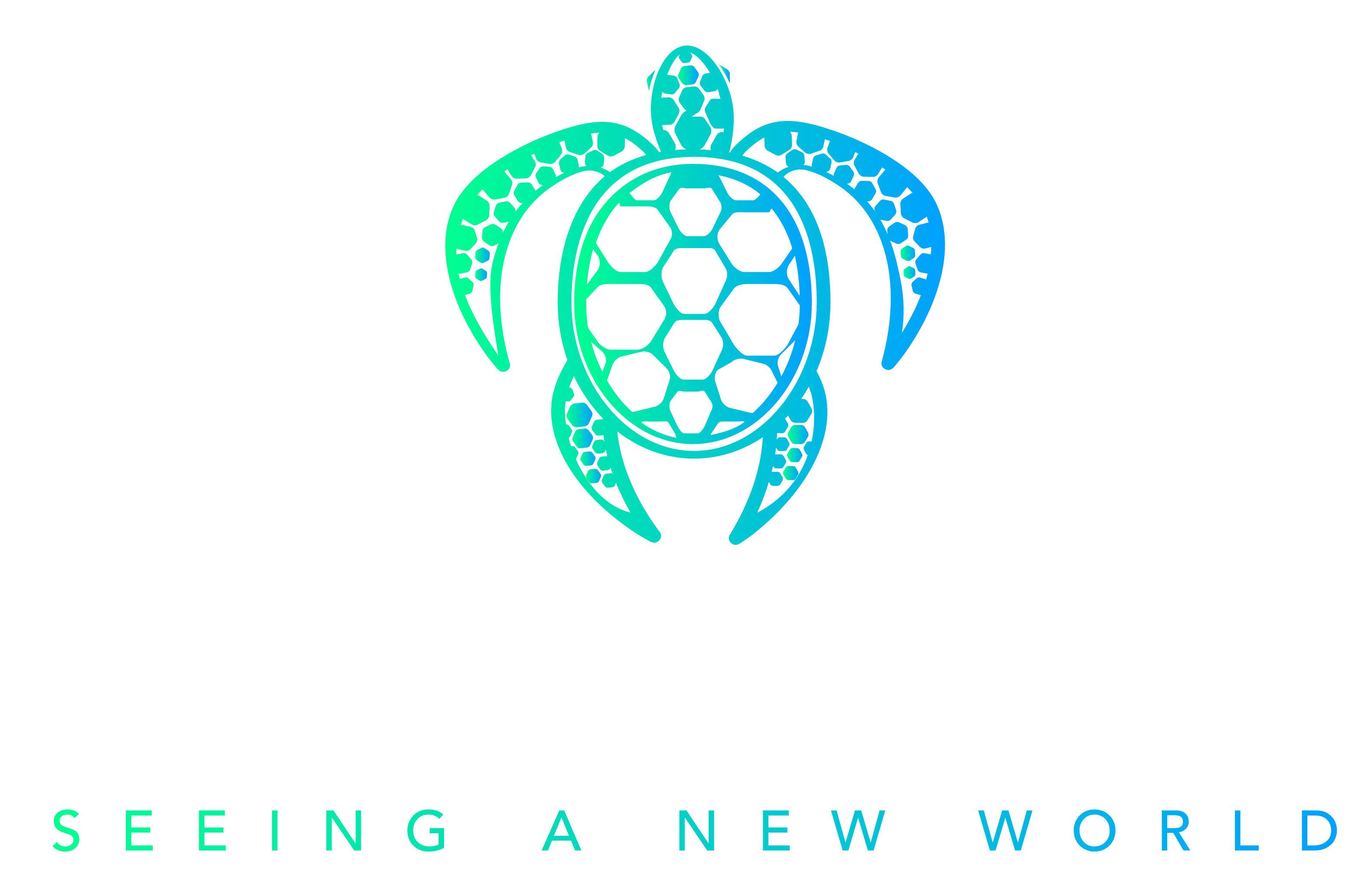



































il mio tesoro è morto 1 mese fa sui Grigioni. Aveva 35 anni. Andava in montagna perchè diceva che là si sentiva VIVO. E mentre si sentiva vivo è morto.Non riesco ancora a incamerare ciò che è accaduto. E’ pazzesco. Non c’è più.