
Manaslu 1979: Toio verso C2. Foto arch. Toio de Savorgnani
Intervista a Vittorio “Toio” de Savorgnani, protagonista con Lorenzo Massarotto, Maurizio “Manolo” Zanolla, Elvio Terrin, Marco Simoni e Bruno Di Lenna, della spedizione del ‘79 all’ottavo Ottomila più alto del mondo
di Vittorino Mason
Nel 1979 un gruppo di ragazzi dediti all’alpinismo, ma figli del ’68, e per questo fuori da qualsiasi schema accademico, sfruttarono un’occasione per andare a scalare un ottomila mettendo in discussione regole non scritte e comportamenti consolidati, imposti dalle grandi spedizioni. Senza soldi, né mezzi, né esperienza volevano scalare il Manaslu (8.163 m), “La montagna dell’anima”, l’ottavo ottomila per ordine di altezza, che si trova nell’Himalaya del Nepal, e non per la via normale, già di per sé difficile, ma per una via nuova: la East Ridge, senza l’uso di ossigeno supplementare.
Questa spedizione, almeno per l’Italia, fu una svolta. Basti pensare alle precedenti spedizioni, costose, con un alto numero di partecipanti e portatori, ma soprattutto pensate per il prestigio nazionale del dopoguerra.
L’anno prima, nel 1978, Lorenzo Massarotto era stato invitato a partecipare a una spedizione all’Everest programmata per il 1980, dove, oltre a Kurt Diemberger, dovevano far parte oltre trenta alpinisti. Lorenzo accettò, ma poi pensò di anticipare l’esperienza extraeuropea con una propria spedizione e qualche mese dopo fortuna volle che trovò un permesso per salire il Manaslu per sole 800 mila lire, invece che 10/20.000 dollari.
Così nel 1979 a formare quella masnada di ragazzi che per un pelo non raggiunsero il Manaslu lungo una via nuova c’erano: Lorenzo Massarotto (1950) capo spedizione, personaggio particolare che a quasi trent’anni, tutti passati nella pianura padovana, si era innamorato dell’alpinismo e decise di dedicare ad esso la vita. In pochi anni aveva raggiunto risultati importanti, con una grande determinazione.
Maurizio Zanolla (Manolo) che ha rivoluzionato la tecnica dell’arrampicata moderna, un ragazzo esagerato, radicale, anarchico da tutti i punti di vista, inconsapevole innovatore, che dedicava le vie agli studenti caduti nelle manifestazioni politiche di quegli anni. Quello che Reinhold Messner ha saputo fare con le salite himalayane, spostando molto in avanti il limite del presunto impossibile, Manolo lo ha fatto per l’arrampicata in roccia.
Elvio Terrin, un veneziano soprannominato “Tarzanetto matto” che affrontava le pareti con un k-way e scarpe da ginnastica, le famose Tepa, anche per le invernali dolomitiche, con una resistenza straordinaria, pari solo all’incoscienza.
Marco Simoni, del Primiero, viaggiatore dell’Asia e hippy, fratello di una guida alpina che aveva raggiunto la cima del Dhaulaghiri, alpinista per istinto. Dopo la spedizione se ne andò a vivere in Australia.
Toio de Savorgnani, mezzo friulano e mezzo cimbro, legato alla figura del Bonatti, ma anche ai romantici e contradditori esploratori dell’800, attratto dalle culture orientali, con un’esperienza alpinistica relativamente limitata, sicuramente non adatta ad affrontare un gigante himalayano, ma con una grande resistenza fisica.
Bruno Di Lenna, dentista padovano con l’ossessione dei viaggi; aveva fatto il medico tra gli Yanomami in Amazzonia, nessuna esperienza di alpinismo, ma fu l’unico medico ad accettare di far parte di quella spedizione organizzata in tempi molto brevi.
Formata la squadra poi fu una corsa contro il tempo; quel gruppo di squattrinati riteneva la determinazione più importante dei soldi, così cominciarono a contattare le ditte specializzate in abbigliamento e materiali di montagna per averli gratis in cambio di un po’ di pubblicità. Alla fine il gruppo aveva così tanto materiale che quando venne il momento di imbarcarlo in aereo erano in soprappeso e Lorenzo si inventò la scusa che andavano a scalare il K2, così gli fu abbuonato.
La spedizione raggiunse quasi gli 8000 metri della cresta

Manaslu 1979: prima foto ricordo al Campo Base, dopo la cerimonia di insediamento con Lama, Sherpa e portatori. Foto arch. T. de Savorgnani
Molte furono le disavventure e gli imprevisti ai quali i sei dovettero far fronte, ma alla fine, nonostante la vetta non sia stata raggiunta e il costo pagato in termini fisici sia stato elevato, la spedizione al Manaslu non fu un fallimento.
Se si pensa con quali pochi mezzi e partecipanti sia stata realizzata, che Lorenzo Massarotto assieme ad Ang Dorje riuscì quasi a raggiungere gli ottomila metri della cresta e che altri due, Toio de Savorgnani ed Elvio Terrin raggiunta la quota di 7500 metri circa, senza l’arrivo del brutto tempo avrebbero potuto salire in vetta per una via nuova di V+ e con un passaggio di VI, be’, bisogna proprio dire che, anche senza raggiungere la cima, la spedizione al Manaslu è stata una grande impresa dal punto di vista alpinistico e una straordinaria avventura da quello umano.
Dopo quella spedizione Lorenzo Massarotto si dedicò completamente all’apertura di vie su roccia molto difficili e così Manolo, Lorenzo però il 10 luglio del 2005 fu colpito da un fulmine sulle Piccole Dolomiti che mise fine alla sua vita, Marco Simoni emigrò, Elvio Terrin tornò alla sua vita e all’arrampicata, Bruno Di Lenna lasciò la montagna per dedicarsi alla musica classica e Toio all’ecologia e alla tutela della foresta, non solo del Consiglio, ma anche di molte altre montagne, essendosi impegnato nell’associazione Mountain Wilderness Italia, di cui è stato anche presidente nazionale.
Recentemente Manolo ha riportato in auge questa esperienza al Manaslu nel suo libro “Eravamo immortali”, per cui ci sembrava interessante sentire anche un’altra voce, una voce che di quel ricordo porta in sé il tono greve e doloroso di una grande perdita e allo stesso tempo di una grande conquista.
Intervista a Toio de Savorgnani

Il Manaslu visto da C2. La punta di destra è l’anticima, più bassa della cima vera e propria, sulla sinistra. Foto arch. Toio de Savorgnani
Toio, perché di questa spedizione non se n’è mai parlato se non in questi ultimi anni?
Forse perché eravamo tutti molti giovani e politicamente impegnati, schierati o ideologicamente molto vicini a quello che in quegli anni era il movimento della protesta. Ma soprattutto con quella spedizione noi abbiamo infranto tutte le regole, anche quelle non scritte delle spedizioni di quel periodo. Per molti versi noi siamo stati estremamente scomodi.
Però, se avessimo raggiunto la cima, forse se ne sarebbe parlato rappresentando anche un interesse e prestigio nazionale che avrebbe fatto chiudere un occhio, forse anche due, sul modo con la quale l’avevamo raggiunta.
È vero che ti chiesero di partecipare alla spedizione perché eri l’unico che sapeva un po’ di inglese? Cosa significava per te esserci?
Sì è abbastanza vero…, nel 1978 ero impegnato al Giardino Botanico Alpino al Rifugio Vazzoler, sulla Civetta, dove avevo conosciuto Lorenzo e con lui avevo ripetuto delle vie. Un giorno mi chiese se mi interessava partecipare alla spedizione al Manaslu e sopratutto se parlavo l’inglese.
Fin da bambino ho sempre avuto la passione per l’esplorazione e quando mi chiedevano cosa volevo fare da grande, io rispondevo “l’esploratore e esplorare l’Asia”.
Già alle elementari mi piacevano la geografia e sopratutto l’Asia e quando ho cominciato ad andare in montagna e poi, verso i quindici anni anche ad arrampicare, mi giunse l’eco e il richiamo dell’Himalaya. Ma non avevo un’idea di alpinismo, il mio sogno era quello di salire una grande montagna per conquistarla, quello che mi interessava era il viaggio, la scoperta, la conoscenza di luoghi e culture diverse, soprattutto quelle Indigene, come i Nativi d’America o gli Indios dell’Amazzonia. Con quella spedizione pensavo e speravo di dare inizio a una vita dedicata alla montagna, ma anche all’ esplorazione dei grandi spazi selvaggi e il mio mito di quegli anni era Walter Bonatti.

Toio al Giardino Botanico Alpino del Cansiglio. Foto arch. Toio de Savorgnani
La spedizione al Manaslu è stata una sfida allo status quo del mondo accademico o più frutto del caso?
Entrambe le cose. Devi pensare che la prima volta che ci siamo trovati a discutere tra di noi, la constatazione di partenza per scalare un ottomila è stata quella di dire “non abbiamo soldi”. Considera anche che nessuno di noi aveva scalato un quattromila, seppure alcuni avevano ripetuto vie importanti nelle Dolomiti e in invernale.
Sicuramente la determinazione di Lorenzo Massarotto nel voler a tutti i costi andare in Himalaya è stata determinante, ma anche la coincidenza nell’aver trovato un permesso a un prezzo stracciato. Poi, come detto prima, noi, coscienti o incoscienti, abbiamo sfidato lo status quo dell’alpinismo accademico extraeuropeo, cambiando l’approccio e lo stile di scalare un ottomila.
Eravate bene attrezzati?
Sì. Pensa che eravamo tra i primi a usare di cibi liofilizzati che erano stati sperimentati nelle missioni spaziali, avevamo le tende d’alta quota più avanzate, le Denali, piccolissime e resistenti al vento e su consiglio di amici speleo del CAI di Vittorio Veneto, forse fummo i primi, almeno in Italia, ad impiegare in una spedizione in alta montagna i Jumar, le maniglie di risalita in sicurezza. Avevamo poi delle piccozze corte e martelli da ghiaccio che usavamo per la progressione, quello che da lì a poco tempo sarebbe diventata la piolèt traction. Invece le nostre radio erano primordiali e pesanti, durarono solo pochi giorni.

Un difficile passaggio durante l’avvicinamento. Nel 1979 la via verso il Manaslu non era ancora stata facilitata per alpinisti e trekker. Foto arch. Toio de Savorgnani
Già all’arrivo a Kathmandu avete avuto i primi problemi…
Sì. L’agenzia, così come accadeva normalmente allora, voleva realizzare grossi guadagni imponendoci un alto numero di sherpa, invece noi ne volevamo solo quattro. Inoltre tenne bloccato per due settimane il carico con la nostra attrezzatura, dicendoci che era andata perduta, ma era solo un trucco per farci cedere alle loro richieste. Poi in parte riuscimmo a recuperarla, ma il prezioso gas ce lo rubarono. Senza questi disguidi avremmo schivato l’arrivo anticipato del monsone e probabilmente saremmo arrivati in cima al Manaslu.
E poi anche durante l’avvicinamento…
Considera che siamo stati costretti ad andare fino al Campo 1 con un fornello indiano da 30 chili e una bombola dello stesso peso trasportati dai portatori locali fino a 5000 metri, dotati solo di scarpe di tela.. Non bastasse, l’agenzia ci fece fare un percorso di due settimane al posto di una, facendoci perdere ulteriore tempo, evento che poi ci è stato fatale.
Lungo l’avvicinamento usammo la maggior parte dei farmaci che avevamo portato con noi per curare i locali e, una volta al campo base, ci rubarono pure i bidoncini con le terapie per i congelamenti.
Sempre l’agenzia, per paura che non pagassimo, nonostante l’accordo che il conto l’avremmo saldato al ritorno, ci impose il pagamento immediato dei portatori. Noi avevamo lasciato il grosso dei nostri soldi a Kathmandu e per non rinunciare alla salita fummo costretti ad andare a chiedere un prestito dal lama del vicino monastero di Samagon.

Il medico Bruno di Lenna mentre visita un abitante dell’ultimo villaggio di Samagon durante l’avvicinamento. Foto arch. Toio de Savorgnani
Perché una via nuova quando prima della partenza Mario Fantin vi aveva caldamente consigliato di non provarci visto che già la via normale era difficile e pericolosa?
Perché Massarotto aveva comprato il permesso per il Manaslu per quella via, cioè la cresta Est, ma anche perché in tutti noi c’era un grande spirito d’avventura e soprattutto un’incoscienza giovanile. Niente ci sembrava impossibile e, come recita il titolo di un libro di Manolo “ci sentivamo immortali”, non per sprezzo del pericolo, ma proprio perché non si aveva la concezione di quali fossero i pericoli reali.
La nostra via presentava diverse difficoltà: la lunga attraversata in diagonale, dopo il Campo 2 a 6000 m, esposta e pericolosa per le frequenti cadute di sassi e delicata per la necessità di passare attraverso le numerose canne d’organo di neve ghiacciata; furono Manolo e Marco a superarla per primi. La lunga diagonale terminava con un couloir ghiacciato che sbucava su una cresta affilatissima a 6000 metri dove iniziava il grande plateaux, non difficile, ma pieno di seracchi insidiosi.
Sì, io contattai Mario Fantin per avere delle foto e lui mi cercò parecchie molte volte per tentare di convincermi a non andare ed eventualmente a scegliere la via normale.

Manaslu 1979: Manolo sulle pareti di ghiaccio dopo il Campo 1. Foto arch. Toio de Savorgnani
Lorenzo Massarotto, Elvio Terrin, ma sopratutto Manolo erano certamente due fortissimi scalatori su roccia, ma senza esperienza d’alta quota…
Sì. Come già detto, nessuno di noi aveva mai salito un quattromila. Pensa che in quegli anni era difficile anche reperire qualche immagine della montagna, dal versante che intendevamo salire. Nonostante ciò non ci sentivamo dei folli, non avevamo la consapevolezza di andare ad avventurarci in qualcosa di molto pericoloso.
E tu che esperienza avevi di montagna e di alta quota?
Prima del Manaslu la cima più alta che avevo salito era la Civetta. Diciamo che avendo studiato Scienze Forestali e avendo operato al Giardino Botanico al rifugio Vazzoler, ero più portato allo studio della flora che all’arrampicata, ma quel via vai di alpinisti al rifugio e sulle molte vie della Civetta sopra di me, in quelli anni considerata l’Università del sesto grado, hanno influito anche sul mio spirito di avventura.
I miei inizi però furono sul greto del Piave in Val Gallina. Lì si trovava la palestra che era punto di riferimento per molti alpinisti bellunesi; ci veniva anche Mauro Corona perché la palestra di Erto ancora non si conosceva. Arrampicavo con gli scarponi di cuoio rigidi, i moschettoni di ferro e la corda di canapa, poi è giunta l’amicizia con Lorenzo e le vie da secondo fino al sesto grado. Dei cinque alpinisti ero quello più scarso.

Manaslu 1979: Lorenzo Massarotto, capo spedizione. Foto arch. Toio de Savorgnani
Com’era Lorenzo Massarotto da capo spedizione? Schivo e silenzioso come nel suo carattere, oppure loquace e autorevole?
Lorenzo era abbastanza schivo, soprattutto durante l’avvicinamento rimaneva molto tempo da solo. Poi, durante le prime salite in quota, sono iniziati i primi contrasti fra di noi. In quelle condizioni difficili, basta poco per esasperare gli animi, far perdere il controllo e reagire male nei confronti dei compagni. Succede molto spesso nelle spedizioni.
Anche se eravamo un piccolo gruppo: cinque alpinisti e un medico che è riuscito ad arrivare solo fino al Campo 1, tutti noi eravamo molto eterogenei, dei personaggi molto particolari e con un carattere forte. Ognuno andava per la sua strada. Lorenzo era sì il capo spedizione, nessuno lo metteva in discussione, ma ognuno agiva quasi sempre in base alle proprie scelte. Considera che la via al Manaslu era lunga 10 chilometri ed eravamo sempre sparpagliati e senza radio, così i rapporti fra di noi erano rari o in coppia: Bruno rimaneva al Campo Base, io stavo con Elvio e con Lorenzo, mentre Manolo e Marco erano sempre per conto loro.
Nonostante ciò, questo non ha influito negativamente sull’esito della spedizione.

Manaslu 1979: il piccolo Campo Base. Foto arch. Toio de Savorgnani
Chi di voi decideva il lavoro da fare? Come eravate organizzati?
Cercavamo di prendere le decisioni insieme tenendo conto che Lorenzo era il capo spedizione, ma poi ci si comportava in base alle scelte del momento. Eravamo dei giovani un po’ anarchici e alla fine ognuno rivendicava il proprio pensiero.
Però, una delle decisioni prese di comune accordo fu di porre i campi a 1000 metri di dislivello uno dall’altro invece che dei comprovati 500 metri. Una soluzione innovativa per ovviare alla scarsità di cibo e tende. Un’altra è stata quella di salire senza bombole ad ossigeno, per ovviare alla mancanza di soldi e di portatori. Ne avevamo solo un paio di piccole da usarsi solo in caso di mal di montagna.

Manaslu 1979: 1) L’ambulatorio che usavamo ogni giorno anche per le popolazioni indigene. Foto arch. Toio de Savorgnani
L’altra cosa decisa subito fu che il medico rimanesse al Campo Base da supporto, da riferimento per i portatori e da collegamento con la gente dei villaggi sottostanti. Avendo tempo a disposizione si recava spesso al villaggio di Samago, il più vicino al Campo Base, per curare la gente con i pochi medicinali, ma soprattutto con l’agopuntura.
Il mio compito era quello di portare i carichi avanti e indietro, anche perché avevamo solo quattro sherpa, che non sono dei portatori, ma degli alpinisti e salivano con meno peso di noi sulle spalle. L’essere obbligato a salire e scendere continuamente dai Campi 1, 2 e 3 mi ha permesso di acclimatarmi bene alla quota.

Manaslu 1979: Toio verso C2. Foto arch. Toio de Savorgnani
Marco Simoni e Manolo hanno aperto il tratto chiave della via…
In quei giorni Massarotto era andato un po’ in crisi, così furono loro a cimentarsi per primi in quella lunga diagonale di circa 1500 metri che si trovava dopo il Campo 2, a 5200 metri.
Un traverso molto pericoloso perché esposto alle scariche di sassi e con difficoltà su ghiaccio e misto fino al V+ e con un passaggio di VI. La via era assai delicata anche per la presenza di numerose canne d’organo formate da neve ghiacciata e terminava con un couloir ghiacciato che sbucava a 5500 metri su una cresta molto affilata. Ci volle una settimana per aprire quella diagonale, più di quanto avevamo preventivato.

Manaslu 1979: il grande traverso, passaggio chiave della via, dopo il Campo 2. Foto arch. Toio de Savorgnani

Manaslu 1979: verso C3. Foto arch. Toio de Savorgnani

Manaslu 1979: Lorenzo Massarotto e Ang Dorje alla partenza dal C3 per il primo tentativo diretto alla vetta, non riuscito. Foto arch. Toio de Savorgnani
Alla fine di aprile Massarotto e lo sherpa Ang Dorje raggiunsero gli ottomila metri della cresta, a un passo dalla cima.
Sì, ma prima bisogna fare una premessa. Noi sei ci siamo visti poco o niente dopo la spedizione e ognuno ha detto o riportato una propria versione di cos’è avvenuto.
Massarotto e lo sherpa Ang Dorje partirono dal Campo 3 a 6600 metri per un tentativo diretto alla vetta. Riuscirono a raggiungere quasi gli 8000 metri della cresta e, a quanto riferito poi da Lorenzo, Dorje scivolò e per soccorrerlo lui dovette rinunciare alla vetta per riportarlo quasi di peso fino al Campo Base. Un’altra versione è che giunto a quasi ottomila metri Lorenzo non ce l’abbia più fatta ad andare avanti e siano stati costretti a scendere.
Bisogna anche ricordare che durante la spedizione comunicavamo poco tra di noi, subito dopo quell’avventura l’emergenza era di dover pagare qualche decina di milioni di lire di debiti per i materiali (che non avremmo pagato se avessimo raggiunto la cima…) e che, in seguito, sia Lorenzo che lo sherpa Ang Dorje sono morti, quest’ultimo durante una spedizione di pulizia del Campo Base dell’Everest.

Manaslu 1979: Il Sirdar Ang Dorj (capo degli sherpa, che l’anno prima aveva salito con Messner l’Everest senza ossigeno, primo nepalese a riuscirci) sul grande traverso. Foto arch. Toio de Savorgnani
Tu ed Elvio Terrin il giorno dopo siete riusciti a porre il Campo 4 a 7500 metri
Sì, era il 5 maggio. In compagnia di due sherpa avevamo raggiunto la quota di circa 7500 metri, sulla ripida parete ghiacciata sotto l’anticima. Per scelta gli sherpa decisero di tornare indietro, forse avevano intuito il pericolo di quel campo così esposto. Noi avevamo tutta la notte per recuperare e riposare. Se il tempo avesse tenuto, il giorno dopo in poche ore saremmo arrivati sulla cresta e da lì facilmente in vetta.
Ma quella sera la situazione meteo cambiò radicalmente. Non più la solita bufera violenta che si scatenava ogni giorno con vento forte e freddo, ma senza neve, se non quella mossa dal vento, e con temperature ben oltre i -20°C che poi si placava durante la notte. Quella sera cominciò a nevicare sempre più forte, poi a grandinare e verso le 21.00 scesero le prime slavine, prima leggere, poi sempre più abbondanti, finché una schiacciò del tutto la tenda, trattenuta a stento da grossi ancoraggi in alluminio.
Se avessero ceduto, quelle slavine avrebbero portato la nostra tenda, con noi dentro, 2000 metri di dislivello più in basso, come è accaduto quella notte a qualche altra spedizione, su altri 8000.

Manaslu 1979: Campo 2. Elvio a sinistra e Toio a destra, durante la disperata discesa, due giorni dopo che le valanghe si abbattessero sulle loro tende. Foto arch. Toio de Savorgnani
Si può dire che la vera impresa non è stata quella di salire verso la vetta, ma di scendere verso la salvezza?
Certamente. Elvio ed io eravamo già dentro i sacchi a pelo; io con indosso tutto, perfino gli scarponi, pronto per partire l’indomani. Quando sentimmo la pressione della neve sulla tenda ci preparammo al peggio. Grazie a dei picchetti grandi e molto resistenti la tenda non venne strappata via dalle valanghe. Lì non si poteva rimanere, troppo alto il rischio. Decidemmo di uscire e scendere subito. Rompemmo i teli, riuscimmo a recuperare un paio di ramponi che calzai io, mentre Elvio si tenne l’unica piccozza recuperata in quei concitati momenti di fuga.
La bufera di neve imperversava feroce e la temperatura era probabilmente sui -40°C, dovevamo affrontare un pendio di ghiaccio di oltre 70°. A un certo punto io persi un rampone e non sapendo cosa fare decisi di scendere ugualmente perché altre soluzioni non ce n’erano. Mi lasciai andare in una lunga scivolata che terminò in mezzo alla neve soffice. Elvio mi imitò raggiungendomi poco dopo.
Io avevo sei paia di guanti e li persi tutti, e così anche Elvio. A mani nude, nel buio, in mezzo ad una bufera, senza punti di riferimento ed evitando pericolosi seracchi non so come riuscimmo miracolosamente a raggiungere le due piccole tende del Campo 3 a 6600 metri.
Riuscìi ad aprire e richiudere la cerniera della tenda con la bocca. Avremmo voluto riscaldare dell’acqua, ma le mani erano inutilizzabili. Ricordo che Elvio tentò di recuperare la circolazione delle mani sbattendole contro i pali di alluminio della tenda e queste, da quanto dure fossero, tintinnavano!
In quella discesa avevo perso il senso del tempo, del pericolo e del dolore. Nonostante avessi le mani congelate, non sentivo più niente. Ero entrato in una sorta di trance. Poi ci infilammo nei sacchi a pelo e con le mani in cerca di tepore sugli inguini passammo quella notte. Il mattino dopo inaspettatamente giunsero i due sherpa che la sera prima non erano riusciti a raggiungere il campo e per nostra fortuna decisero di scavarsi una truna e passare la notte fuori.
Con le mani fuori uso, aiutati dagli sherpa, ci apprestammo a scendere fino al Campo 2. Nonostante il sole, quel giorno c’era una nebbia che non permetteva di vedere ad un passo, non so come riuscimmo ad attraversare il grande plateaux senza alcun punto di riferimento e poi arrivare al difficile traverso. Fummo poi raggiunti e aiutati da Marco e Manolo che stavano salendo per tentare a loro volta la cima. Scendemmo con loro e raggiungemmo il Campo 2 a sera inoltrata.
Manolo invece non si fermò e di notte compì una veloce discesa lungo pericolosi canaloni per raggiungere, alle prime luci dell’alba, il Campo Base (3800 m), e poi un villaggio di confine da dove chiamare i soccorsi via radio. Due giorni dopo, grazie all’intervento di un elicottero dell’esercito nepalese, rientrammo a Kathmandu e da lì, con l’aiuto determinante dell’ambasciatore italiano, in Europa.

18) La partenza di Elvio e Toio che dal campo base verranno trasportati in elicottero a Kathmandu. Foto arch. Toio de Savorgnani
Dopo che tu ed Elvio siete scesi ci fu un altro tentativo alla vetta
Lorenzo, Marco e Manolo tentarono ancora una volta di raggiungere la vetta, ma sul Manaslu tutto era cambiato: bufere sempre più violente e valanghe sempre più forti, fino all’avvertimento finale. Dormivano in tre in un’unica tendina, di notte udirono forti boati e movimenti del ghiaccio, al mattino scoprirono che la seconda tenda, a due metri di distanza, era stata inghiottita in un profondo crepaccio, appena apertosi.
L’avvertimento era stato molto chiaro e non ebbero alcun dubbio. Era giunto il tempo di scendere e tornare a casa.
Cos’è andato storto? Non potevate prevedere l’arrivo del brutto tempo?
No. Non avevamo neppure le radio. Oggi con tutte le strumentazioni moderne un alpinista riesce ad avere le previsioni per le 4, 5 ore successive o comunicare in diretta cosa sta facendo a ottomila metri, allora non riuscivamo neanche a comunicare fra di noi.
Poi devi pensare la straordinarietà del monsone in anticipo di quasi un mese rispetto al solito, e noi lo abbiamo saputo solo dopo gli accadimenti. Di critiche poi se ne possono fare quante se ne vuole, ma il fatto che nessuno di noi sia morto è già un miracolo. Quella notte sono stati molti gli incidenti accorsi a spedizioni impegnate sugli ottomila nepalesi, con ben sette i morti.
Quanto è durata la spedizione?
Partiti agli inizi di febbraio, per me ed Elvio fino ai primi di maggio, invece Lorenzo, Manolo e Marco giunsero in Italia il 15 di agosto. Dopo l’incidente rimasero al Manaslu un’altra settimana e per scendere fino a valle impiegarono un’ulteriore settimana.
Una volta a Katmandu videro il loro volo di ritorno bloccato per degli incidenti aerei, poi, con i tempi asiatici i loro biglietti scaddero. Non avevano soldi per comprarne di nuovi e ci vollero tre mesi di attesa per ottenere quelli sostitutivi. Nel frattempo, dopo aver venduto gran parte dell’attrezzatura per racimolare qualche soldo, i tre trascorsero del tempo a Kathmandu e poi in India, a Srinagar, cercando di vivere con poche rupie, mangiando il minimo indispensabile e dormendo nei posti più spartani. Quando tornarono a casa erano irriconoscibili: avevano perso tutti almeno 20 chili!

Manaslu 1979: 8) Il grande pinnacolo visto dal campo 2, con le piccole tende Denali, allora considerate le migliori in assoluto per l’alta quota. Foto arch. Toio de Savorgnani
Ripensandoci pensi che allora eravate sei sprovveduti?
Non sei sprovveduti, ma degli avventurosi, che hanno affrontato questa esperienza con lo spirito dei vecchi esploratori. Eravamo abbastanza coscienti dei rischi che correvamo ma gli abbiamo accettati con una certa leggerezza esistenziale.
In quegli anni, Everest a parte, il Manaslu era l’8000 che aveva fatto più vittime; nel 1972 ben 17 morti, dei quali ben 11 a causa della caduta di un seracco e in seguito ci furono altri eventi drammatici, come i 13 morti del 2012 per una grande valanga. Anche il famoso Hans Kammerlander ha sperimentato di persona la durezza del Manaslu. Per ben tre volte ha tentato di salirlo senza riuscire a raggiungere la vetta e perdendo i più cari compagni di cordata. Dopo aver salito ben 13 dei 14 ottomila, il solo Manaslu lo ha respinto e proprio a causa delle bufere.
Tu ed Elvio dove siete andati a curarvi i congelamenti?
All’ospedale civile di Innsbruck. Era stato Reinhold Messner, che avevamo incontrato prima della spedizione, a consigliarci, di andare lì in caso di congelamenti. All’ospedale di Innsbruck ci siamo arrivati con le nostre forze l’11 maggio, dopo un lungo volo Kathmandu-Vienna e un viaggio in treno con indosso ancora i vestiti da alta quota. All’ospedale giunsero poi altri tre alpinisti di altre spedizioni, reduci da quella stessa, tragica notte.
Lì subimmo l’amputazione di gran parte delle falangi, ma se non fosse stato per le terapie ricevute saremo tornati a casa senza nessun dito delle mani. Siamo rimasti lì tre mesi, fino al 15 agosto. Il primo periodo abbiamo dormito molto per recuperare le fatiche e lo stress, ma anche perché avevamo i piedi congelati e inutilizzabili. Io ero arrivato a pesare solo cinquanta chili. Nonostante tutto non è stata una brutta esperienza neanche quella perché l’abbiamo presa con leggerezza e quasi quasi posso dire che ci siamo anche divertiti.

Manaslu 1979: 17) Toio al campo base con le mani congelate. Foto arch. Toio de Savorgnani
Come hai reagito all’amputazione di otto falangi delle mani?
Con molta serenità, ero già contento di essermela cavata. L’esperienza al Manaslu mi ha dato una grande forza perché ho capito che quello che è successo non era la fine di una storia, ma l’inizio. Mi si sono aperte molte porte nuove e ho cominciato ad affrontare le difficoltà della vita con molto meno timore ed apprensione e una grande determinazione. Mi ero fatto l’idea che se ero riuscito a tornare – o qualcuno qualcosa mi avevano concesso di farlo…– da un’esperienza come quella, nulla poteva più farmi paura.
Sei riuscito a metabolizzare il tuo corpo con una parte mancante?
Sì perché ho avuto subito la lucidità e la consapevolezza di capire che se mi lasciavo abbattere da questa perdita avrei passato tutto il resto della vita da invalido, cosa che io non volevo. A tutti gli effetti mi sono sempre sentito una persona normale.
Avevi messo in conto la possibilità di morire o perdere qualcosa lassù?
No. C’era sì quell’ansia che ti prende la notte che precede una scalata impegnativa, ma niente di più. Prima di partire, e poi durante la spedizione, ero come entrato in una dimensione onirica: non avvertivo più il pericolo, il freddo e la fame. Come quel giorno che eravamo al Campo 2 e ci arrivò la notizia delle lettere giunte da casa. Io partii subito per scendere al Campo Base, ma non ci riuscii. Trascorsi la notte all’addiaccio, sotto un grande masso, in compagnia di un fuocherello. Al mattino, quando mi svegliai, scoprii che il leopardo delle nevi aveva girato lì attorno per tutta la notte.
Facevo delle cose difficili e pericolose, non da incosciente, ma con la leggerezza da compagna. Forse questo è lo stato d’animo migliore per affrontare le situazioni senza farsi prendere dall’angoscia.

Manaslu 1979: tracce del leopardo delle nevi che visitava ogni notte i campi poiché gli alpinisti mettevano fuori dalla tenda gli avanzi di cibo. Foto arch. Toio de Savorgnani
Com’è stato tornare alla quotidianità senza più la possibilità di scalare?
Come non fosse accaduto niente. Sono tornato subito a lavorare come operaio forestale e a svolgere in Cansiglio l’attività di accompagnatore naturalistico per gruppi e scolaresche.
Proprio perché lo scopo della mia esperienza al Manaslu non era quello di conquistare una cima, ho sempre dedicato il mio tempo non all’alpinismo, ma alla conoscenza della montagna. Dopo l’amputazione delle falangi ho comunque arrampicato ancora, ma per me è sempre stato più importante vivere la montagna nella sua totalità, soprattutto dal punto di vista ecologico e naturalistico, e impegnarmi per la sua tutela. Ecco perché sono entrato a far parte di Mountain Wilderness.
Ogni tanto maledici di aver saputo l’inglese ed essere andato al Manaslu?
No. Quando mi hanno fatto la proposta ho accettato con gioia. È stata un’esperienza fondamentale della mia vita. Mi ha aiutato a conoscermi profondamente. Se non avessi potuto farla ora sarei un’altra persona. Molte scelte che poi ho fatto sono state figlie di quella grande avventura che mi ha permesso di affrontare altri ostacoli della vita con uno spirito sempre positivo e senza troppi timori.
Quanto è difficile vivere senza le dita delle mani?
Il mio stato d’animo positivo mi ha subito fatto capire che la menomazione non mi avrebbe impedito di fare ciò che potevo fare prima. Ora mi comporto come avessi le dita intatte e riesco a fare con le mani ciò che alcune persone non sono capaci. Può sembrare incomprensibile, ma tutto ciò che facevo prima delle amputazioni sono riuscito a farlo anche dopo.
Dopo la spedizione vi siete più ritrovati?
Mai più tutti assieme. Gli strascichi della spedizione ci hanno diviso. Prima della spedizione non eravamo amici. Io avevo fatto alcune vie con Massarotto e gli altri non gli conoscevo. Per quanto mi riguarda sono stato e sono molto in contatto soprattutto con Elvio e con Bruno Di Lenna, il medico della spedizione, ma poi negli ultimi anni anche con Manolo.
L’esperienza al Manaslu ti ha insegnato qualcosa?
Il Manaslu mi ha tolto una parte del mio corpo, ma da altri punti di vista mi ha anche dato molto. Quello che sono ora dipende in grande parte dal Manaslu.
Per me tutto quello che è avvenuto è stata una specie di iniziazione. Ora ritengo che nulla è stato casuale; è come ci fosse stato un disegno prestabilito. La lettura che ne ho fatto è che dopo questa esperienza avrei dovuto dedicare la mia vita a raccontare e trasmettere il valore, non solo ambientale, ma anche la sacralità delle montagne per tutelarle e salvaguardarle. Inoltre ho capito che tutti noi abbiamo delle grandi potenzialità, ma che molto spesso rimangono inespresse: bisogna imparare a tirarle fuori.

21) Toio con la bandiera bianca di Mountain Wilderness durante una manifestazione a difesa delle montagne. Foto arch. Toio de Savorgnani
A distanza di quarant’anni da quella quell’avventura, se ti guardi indietro cosa vedi?
È stata un’esperienza eccezionale e un’occasione di grande insegnamento. Da un punto di vista alpinistico direi che se non fosse arrivato il monsone in anticipo avremmo raggiunto la cima per una via nuova almeno in quattro, ma in fondo questo aspetto per me è sempre stato secondario. Quello che invece emerge forte è che andare in posti così è come partire per la guerra: sai quando parti ma non sai quando, se e come torni; ogni giorno è una lotta per la sopravvivenza, ti senti sempre precario, sei attivo, ma indifferente perché se cominci a pensare a ciò che ti può succedere vai fuori di testa.
Invece per Lorenzo Massarotto il Manaslu è stato un fallimento.
Tornato dalla spedizione il suo alpinismo è cambiato radicalmente; si votò alle vie nuove, di grande difficoltà e in solitaria, senza mai rendere pubbliche le sue esperienze, fino a quel fulmine che pose fine al suo transito terrestre. Solo dopo la sua scomparsa si è capito quante vie ha fatto e di che difficoltà.

23) Toio in veste di guida naturalistica nel giardino botanico del Cansiglio. Foto arch. Toio de Savorgnani
Com’è la tua vita oggi?
Sto per andare in pensione dopo 35 anni di lavoro in Cansiglio come operaio forestale e poi come tecnico per conto di Veneto Agricoltura, l’Ente che lo gestisce.
Agli impegni familiari, ho due figlie e una compagna, alterno l’impegno per la difesa della natura e della montagna. Da sempre divulgare la natura e l’ambiente naturale sono stati il mio pensiero fisso. Collaborare con associazioni come Mountain Wilderness, il Cai o esperti naturalisti, organizzare manifestazioni, come ad esempio “La marcia per il Cansiglio”, diffondere informazioni e oppormi alla colonizzazione di stampo urbano, con un turismo invasivo e speculativo, sono stati e sono un impegno che cercherò di portare avanti. All’uso sostenibile e rispettoso dell’ambiente alpino vorrei che si aggiungesse il vincolo di lasciare totalmente integre una parte delle montagne.
La spedizione al Manaslu mi ha insegnato la sacralità della montagna.
Dobbiamo avvicinarci a essa con grande umiltà e rispetto perché noi non sappiamo ancora – o forse lo sapevamo, ma lo abbiamo dimenticato – tutto ciò che vi si trova. C’è del divino nel cuore dei monti, ecco perché in quasi tutte le altre culture del mondo vengono ritenute inviolabili. Fino a quando avrò le forze mi impegnerò per trasmettere la sacralità e l’aura mistica che la montagna e la foresta emanano.

22) Toio che parla durante l’annuale ritrovo a Casera Palantina per la difesa e tutela del Consiglio. Foto arch. Toio de Savorgnani
Vittorino Mason
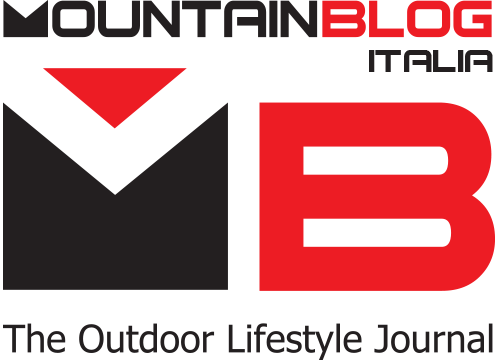




 Action
Action




















































